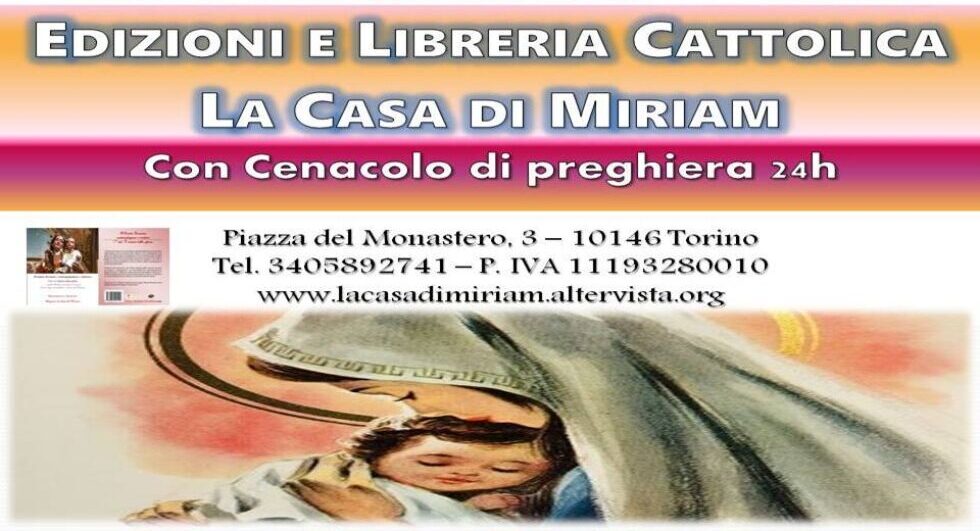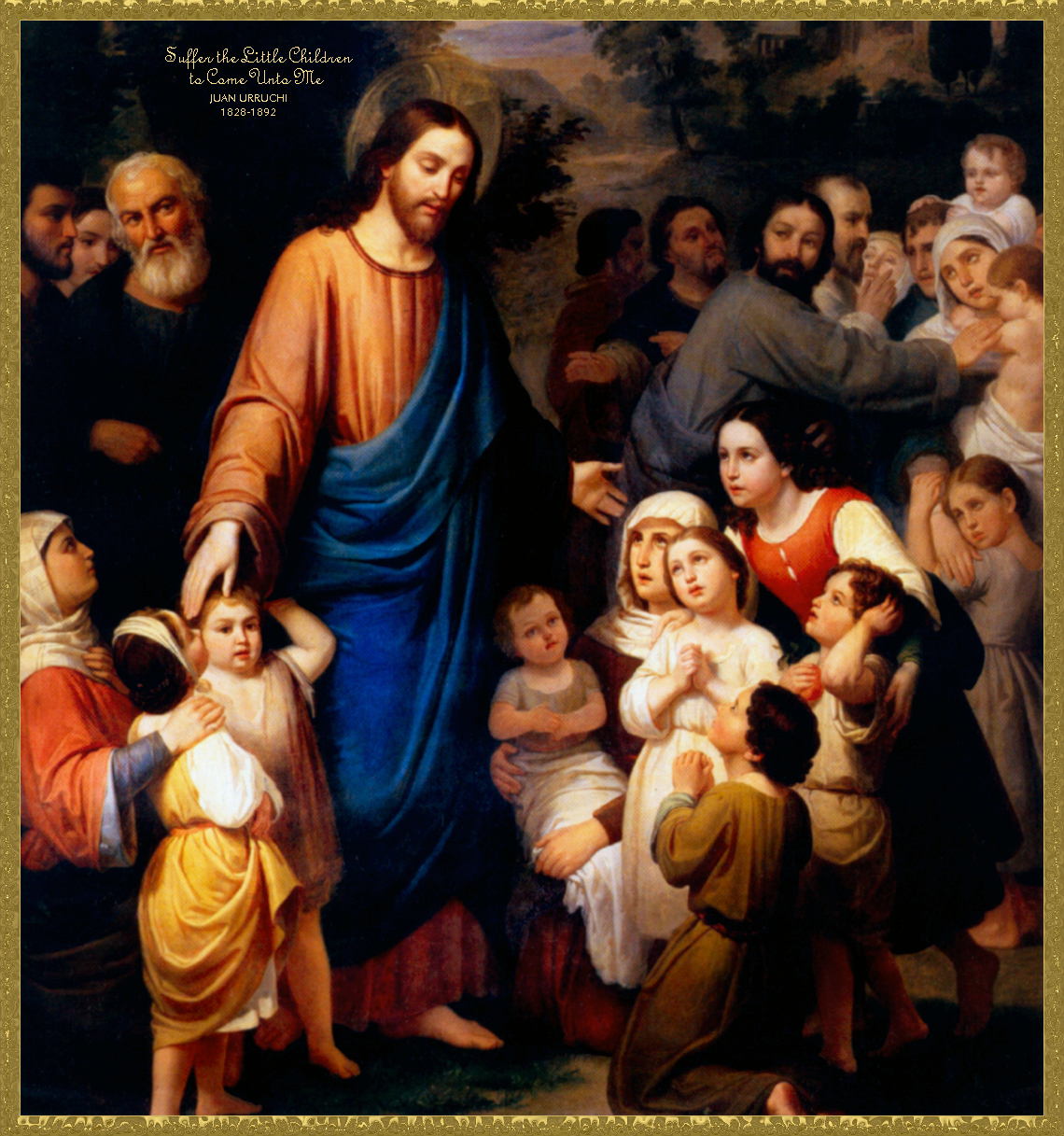
L’evangelista Luca e il coinvolgimento di “tutti” dinanzi agli eventi che narra – Alcune osservazioni letterarie:
In soli 3 versetti, nel testo di Lc 1,57-66, l’Evangelista Luca utilizza 4 volte il termine enfatico “tutti” (greco ‘παντες’) per sottolineare un comune coinvolgimento umano dinanzi all’evento della nascita di Giovanni il Battista e del ritorno della voce a suo padre Zaccaria (cf. Lc 1,63-66). Questo “universalismo” è tipico di Luca, il quale dinanzi agli eventi che narra pone una continua enfasi di tipo assolutistico, come se cioè “tutto” sia coinvolto in ciò che accade, sia a livello soggettivo (ad esempio Maria serbava “tutte” queste cose nel suo cuore, Lc 2,51), sia a livello vocazionale (i discepoli lasciano “tutto” e seguono Gesù, Lc 5,11), sia a livello “demonologico” (Gesù dà ai Dodici il potere su “tutti” i demoni, Lc 9,1), sia ancora a livello cristologico (“Tutte” le cose il Padre ha posto nelle mie mani – dice Gesù in Lc 10,22), sia a livello reattivo dinanzi alla predicazione di Gesù (ad esempio nella sinagoga di Nazaret “tutti” erano presi dall’ira contro di lui, Lc 4,28). Ma sono moltissimi altri, più dettagliatamente, gli esempi che si potrebbero portare sul modo continuo in cui Luca oggettiva il coinvolgimento delle persone, ma anche degli oggetti o degli enti spirituali in un senso “assoluto”, “complessivo”, senza cioè che nessuno di una data categoria sia escluso. “Tutto, tutti, tutte, tutta”, compaiono continuamente nel suo Vangelo. In Lc 6,26, ad esempio, si dice “Guai a voi quando ‘tutti’ parleranno bene di voi”; in Lc 8,52, si dice invece che “tutti” piangevano per la figlia di Giairo; in Lc 9,17, quando Gesù moltiplica i pani, si dice che “tutti” mangiarono e si saziarono. Quando Gesù guarisce l’epilettico indemoniato, ancora, sono “tutti” a restare stupiti (Lc 9,43), e a quelli che non si convertono, Gesù dice che “tutti” periranno allo stesso modo. Dinanzi alla visita alla casa di Zaccheo, “tutti” mormorano (19,7); nel tesoro del tempio la donna anziana pone “tutto” ciò che ha (21,4); nel sinedrio “tutti” domandano se Gesù sia il Figlio di Dio (23,70).
Vi sono poi tanti altri esempi che qui non elenchiamo. Tuttavia questa “continuità” nell’utilizzo di questo termine così enfatico, ossia “tutto” (nelle varie forme possibili, maschile, femminile, singolare e plurale), non appesantisce la narrazione lucana, ma la omologa al fine teologico con il quale essa viene costruita, ossia quello di sollecitare il coinvolgimento teologico di “tutti” i lettori dinanzi all’evento salvifico che Gesù ha realizzato nella storia. Amen
Amen
Edizioni e Libreria Cattolica La Casa di Miriam
Piazza del Monastero 3 – 10146 – Torino