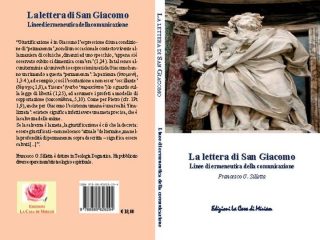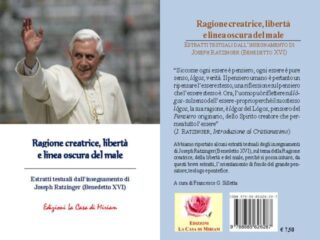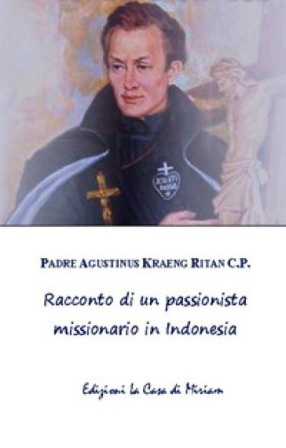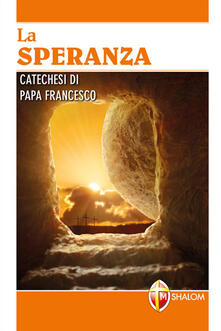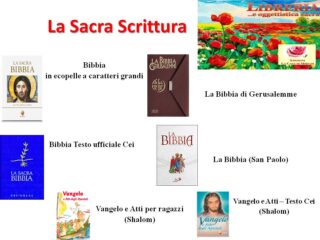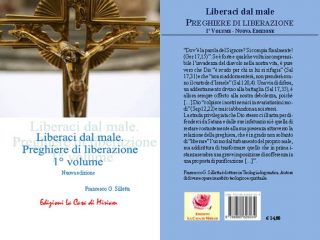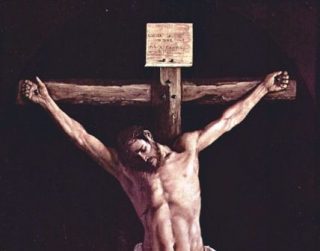Novità: Tutti gli appuntamenti con il Ciprel (Centro Internazionale di Preghiera Laicale ispirato agli scritti di Maria Valtorta):

-
S. Rosario con i testi di Maria Valtorta – (Tutti i giorni alle 14,30 e alle 20,30 fino al 29 marzo)
-
Via Crucis con i testi di Maria Valtorta (Tutte le domeniche alle 15,00 dal 22 febbraio al 29 marzo)
-
Lettura e studio dei Salmi (Tutti i sabati alle 17,30 dal 21 febbraio al 27 giugno)
(Gli incontri avranno luogo nei locali predisposti dalle Edizioni Cattoliche “La Casa di Miriam” – Info: Piazza del Monastero 3 Torino Tel. 3405892741)
Preghiera di benedizione al Sacro Cuore di Gesù ***
4 Volumi: “Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” – di Francesco Gastone Silletta
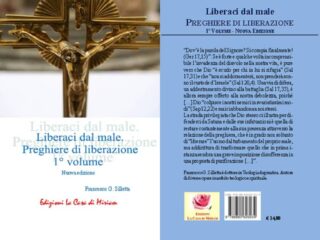
Ti lodiamo e ti benediciamo, dolcissimo cuore di Gesù, per tutto l’infinito amore che lasciandoti trafiggere per noi, ci hai comunicato e continui inesauribilmente a riversare su di noi, immeritevoli di tanta grazia. Ti lodiamo oggi, in questo momento in cui tu, cuore santo, volgi a noi la tua misericordia, e sebbene siamo anime peccatrici e indegne del tuo amore, ci esorti a sperare nella pietà di Dio, a confidare in ciò che umanamente appare impossibile, cioè che un Dio possa amare in un simile modo delle creature così immeritevoli e peccatrici. Per questo ti lodiamo gioiosi, anche per tutti quelli che in questo momento non ti lodano, o ti offendono nei tanti modi con i quali il tuo Nemico li ammaestra contro di te. Sii tu benedetto nei cieli e sulla terra, cuore santissimo del Dio incarnato, affinché ovunque si espanda la potenza del tuo amore e ad ogni anima sia data la possibilità di conoscerti, e conoscendoti di amarti, e amandoti di pentirsi ottenendo il tuo perdono. Nella tua infinita bontà tu vuoi salvare gli uomini, per condurli nel tuo Regno, e sei molto più lieto di premiare le anime, piuttosto che di castigarle. Per questo ti chiediamo di non castigarci e di liberarci da tutto ciò che, in qualsiasi modo, ci leghi ancora al peccato. Noi infatti vogliamo essere come tu ci vuoi, e domandiamo che tutti gli uomini lo diventino, affinché per nessuno sia vano il tuo sacrificio, purissimo cuore di Gesù, trafitto dalla lancia affinché fosse a tutti manifesta l’estensione dell’amore di Dio. Grazie, cuore di Gesù, per come ci hai amati e per il modo ineffabile con cui ancora ci ami, attendendo che tutti possiamo divenire santi come tu ci vuoi. Liberaci per questo, cuore santo di Gesù, da ogni condizionamento del passato e da tutti gli effetti su di noi o sul prossimo dei nostri peccati. Tu che ti sei donato per noi, dona ai nostri cuori l’imitazione di te, affinché immersi nel tuo amore e del tuo amore, il peccato non si appropri mai più di noi, e liberi dal male, possiamo essere totalmente gioiosi verso l’adempimento della tua volontà, che è il miglior premio possibile per noi. Amen.
*** Francesco G. Silletta
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Piazza del Monastero, 3 – Torino
Tel. 3405892741
www.lacasadimiriam.altervista.org
Disponibile il testo:
“Il Pensiero che diventa Parola” –
TEOLOGIA TRINITARIA alla luce degli scritti di Maria Valtorta
VOLUME 1: Excursus storico-introduttivo sulla teologia trinitaria nei secoli –
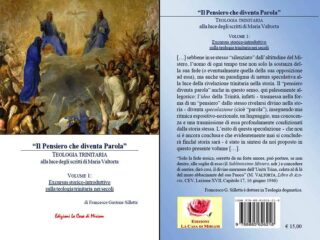
di Francesco Gastone Silletta – 15,00 € – 260 pagine – Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam – Piazza del Monastero, 3 – Torino Tel. 3405892741 www.lacasadimiriam.altervista.org
Indirizzo: Piazza del Monastero, 3 – Tel. 3405892741 – Torino info@edizionilacasadimiriam.it
I testi pubblicati da Francesco Gastone Silletta
(Dottore in teologia dogmatica – Titolo conseguito presso la Pontificia Università della Santa Croce) :
 di Francesco Gastone Silletta € 7,50
di Francesco Gastone Silletta € 7,50
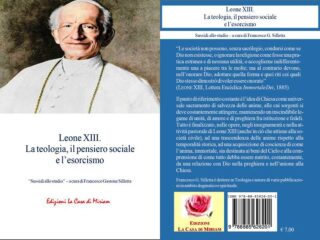 di Francesco Gastone Silletta € 7,00
di Francesco Gastone Silletta € 7,00
 di Francesco Gastone Silletta € 19,00
di Francesco Gastone Silletta € 19,00
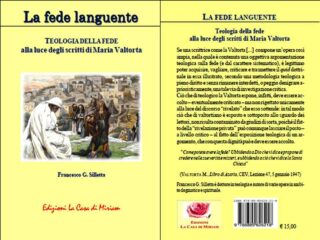 di Francesco Gastone Silletta € 19,00
di Francesco Gastone Silletta € 19,00
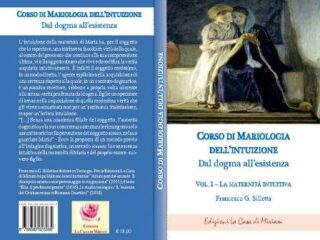 di Francesco Gastone Silletta € 7,50
di Francesco Gastone Silletta € 7,50
 di Francesco Gastone Silletta € 37,00
di Francesco Gastone Silletta € 37,00
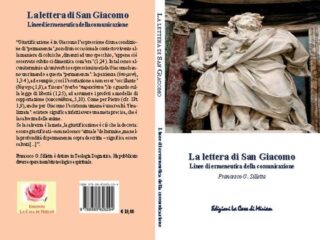 di Francesco Gastone Silletta € 37,00
di Francesco Gastone Silletta € 37,00
 di Francesco Gastone Silletta € 19,00
di Francesco Gastone Silletta € 19,00
 di Francesco Gastone Silletta € 7,00
di Francesco Gastone Silletta € 7,00
 di Francesco Gastone Silletta € 15,00
di Francesco Gastone Silletta € 15,00
 di Francesco Gastone Silletta € 12,00
di Francesco Gastone Silletta € 12,00
 di Francesco Gastone Silletta € 15,00
di Francesco Gastone Silletta € 15,00
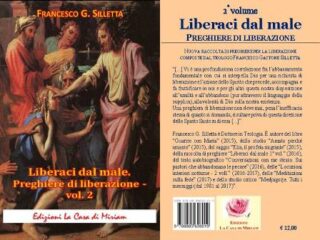 di Francesco Gastone Silletta € 15,00
di Francesco Gastone Silletta € 15,00
 di Francesco Gastone Silletta € 10,00
di Francesco Gastone Silletta € 10,00
 di Francesco Gastone Silletta € 10,00
di Francesco Gastone Silletta € 10,00
 di Francesco Gastone Silletta € 15,00
di Francesco Gastone Silletta € 15,00
 di Francesco Gastone Silletta € 12,00
di Francesco Gastone Silletta € 12,00
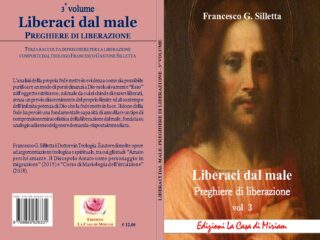 di Francesco Gastone Silletta € 12,00
di Francesco Gastone Silletta € 12,00
 di Francesco Gastone Silletta € 12,00
di Francesco Gastone Silletta € 12,00
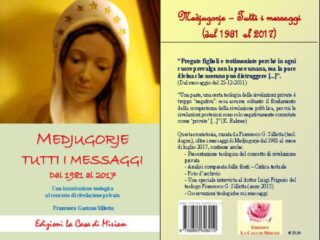 di Francesco Gastone Silletta € 25,00
di Francesco Gastone Silletta € 25,00
 di Francesco Gastone Silletta € 15,00
di Francesco Gastone Silletta € 15,00
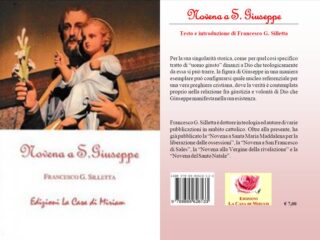 di Francesco Gastone Silletta € 7,00
di Francesco Gastone Silletta € 7,00
 di Francesco Gastone Silletta € 6,00
di Francesco Gastone Silletta € 6,00
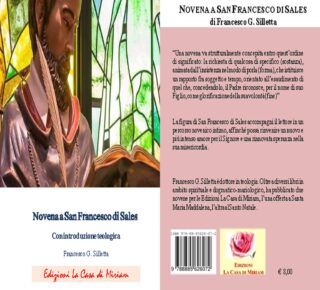 di Francesco Gastone Silletta € 8,00
di Francesco Gastone Silletta € 8,00
 di Francesco Gastone Silletta € 7,00
di Francesco Gastone Silletta € 7,00
 di Francesco Gastone Silletta € 8,00
di Francesco Gastone Silletta € 8,00
 di Francesco Gastone Silletta € 6,00
di Francesco Gastone Silletta € 6,00
 di Francesco Gastone Silletta € 10,00
di Francesco Gastone Silletta € 10,00
 di Francesco Gastone Silletta € 15,00
di Francesco Gastone Silletta € 15,00
Novità:
Nasce a Torino il Ciprel
(Centro Internazionale di preghiera laicale)
ispirato all’insegnamento di Maria Valtorta. Gli incontri si terranno una volta al mese,
nella Chiesa di San Benedetto, la domenica pomeriggio
Il Libretto costitutivo
© Edizioni La Casa di Miriam
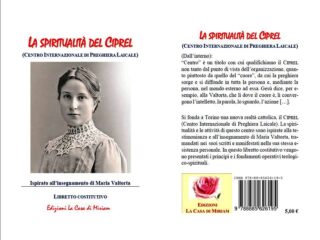
“La preghiera è azione d’amore”
In un passo della sua opera più conosciuta, ovverosia “L’Evangelo come mi è stato rivelato”, Gesù dice alla Valtorta: “Quando pregate, unitevi sempre, sempre, sempre a me. Io pregherò a voce alta per voi, coprendo la vostra voce di uomini con la mia di Uomo-Dio. Io metterò sulle mie mani trafitte la vostra preghiera e l’eleverò al Padre. Diverrà ostia di pregio infinito. La mia voce fusa con la vostra salirà come bacio filiale al Padre, e la porpora delle mie ferite farà prezioso il vostro pregare. Siate in me se volete avere il Padre in voi, con voi, per voi” (Volume I, Capitolo 44,14).
Con queste parole, Gesù ci indica una duplice latitudine fondamentale della preghiera. La prima riguarda essa stessa in quanto tale, come colloquio dello spirito con Dio. Essa, quanto più è limpida, umile, sincera, fervente, continuativa nello spirito, tanto più manifesta la sua fecondità e si traduce in grazia da parte di Dio.
La seconda, invece, partendo da questo presupposto, esprime ed insieme esalta la funzione mediatrice del Figlio presso il Padre, in relazione alle preghiere che noi gli offriamo. Lui si dichiara unito a noi, “amplificatore” presso il Padre delle nostre intenzioni, purificatore della inevitabile umanità della nostra spiritualità, mediante l’intercessione della sua umano-divinità presso il Padre. Con Gesù accanto – e ci è accanto ogni volta che due o tre (cifra evidentemente simbolica per rendere l’idea di una “comunità” di persone) si riuniscono nel suo Nome e invocano Dio, nel comune linguaggio della preghiera, cf. Mt 18,20 – Gesù agisce con la sua presenza filiale, accogliendo le nostre intenzioni e consegnandole, nel lavacro purificatore del suo sangue, al Padre in nostro favore.
Questa duplice latitudine della preghiera, della quale spesso non siamo attualmente consapevoli, può spronarci, da un lato, a un impegno maggiore nella dedizione oratoria e, dall’altro – alla luce della compartecipazione di Gesù alla nostra spirituale attività – rinnovare la nostra speranza, sapendo che ci ode colui che invochiamo e che è cosciente di ciò che domandiamo colui a cui ci rivolgiamo (cf. Sal 93,9).
La presenza di Gesù non soltanto “al di là” della nostra preghiera (nel senso stretto del termine, cioè estrinseco a essa), ma più intimamente nel “qui” dinamico della preghiera stessa (ossia nella sua stessa elaborazione), rende insieme più entusiasmante e responsabile la preghiera stessa. L’entusiasmo è dovuto dal superamento metodico – prodotto dalla compartecipazione di Gesù – di alcuni monotoni formalismi stilistici, linguistici o di altra natura che, a motivo di una spenta e stagnante, infeconda “automaticità”, non esaltano lo spirito nella sua sete di Dio e, prima o poi, stancano l’orazione e inducono ad abbandonarla. La responsabilità, dal canto suo, sorge dalla consapevolezza della presenza viva e insieme vivificante la nostra preghiera che Gesù ci offre, e che quindi non può essere emarginata dal soggettivismo dell’orante.
Pregare insieme, con questi fondamenti di coscienza, assume tutta un’altra forma esperienziale, non più solo connessa al puro “senso del dovere spirituale”, né a quel fenomeno che in certi casi sopraggiunge nello spirito quando si soffre, ossia quel ricorso alla preghiera “angosciata”, non essendo radicata in alcuna predisposizione spirituale.
Come dice Gesù alla Valtorta, “liberatevi dalle misure nel pregare” (Ivi, Volume 3, Capitolo 172,6), “La preghiera è azione d’amore” (Ivi).
Se siamo consapevoli di ciò, allora la preghiera diviene un flusso fecondo di comunione con Dio, senza alterazioni prodotte dal superficialismo del cuore, dalla distrazione dell’intelletto o dall’inedia dello spirito.
La pace come disposizione dello spirito
In un altro momento dell’opera valtortiana, Gesù dice: “Mettetevi nella pace della vostra dimora e soprattutto nella pace della vostra dimora interiore e parlate, angelo di carne fiancheggiato dall’angelo custode, al Re degli angeli […]. Lasciate fuori tutto quanto è mondo” (Ivi).
La pace, nel senso di questa esortazione di Gesù, è il contrario dell’inquietudine e dell’agitazione: esse sono infatti nemiche della fecondità della preghiera, poiché la veicolano verso un errato intendimento di se stessa. Ciò non implica che la preghiera non sorga spesso da contesti o da esperienze di dolore, talvolta intenso, che in qualche modo rendono “sofferta” la preghiera. Gesù non esige che siamo insensibili alla sofferenza. Piuttosto, ci illumina relativamente a quello che nella parabola del seminatore egli stesso ci narra e che può soffocare, come delle spine, il buon esito della preghiera. Queste spine possono rappresentare un simbolo per diverse realtà dell’anima, tutte accomunate, però, dal limite che pongono alla fiducia e alla speranza, le quali devono sostenere la preghiera, essendo questa, come si è visto sopra, un atto di carità. La necessità della pace interiore, quando si prega, diviene quindi fondamentale e, se assente a livello basico, essa va costruita con la preghiera stessa, pregando che Dio conceda una equilibrata condizione di pace nello spirito, affinché la preghiera raggiunga la sua auspicata forma e non venga condizionata da rumori interiori di agitazione o di sfiducia.
Come infatti Gesù ancora istruisce la Valtorta, “la preghiera non è nell’atto, ma nel sentimento” (Ivi, Volume 4, Capitolo 261,5). Ciò non significa che la ragione, nel senso qui dell’attività intellettuale, sia estranea alla preghiera che Gesù insegna. Tanto il cuore quant l’intelletto sono coinvolti nell’unità del soggetto nel tempo del suo colloquio orante con Dio. Piuttosto, tali parole liberano l’idea di una preghiera “standardizzata”, che debba avvenire sempre nei medesimi luoghi o contesti per essere feconda. Gesù qui sta parlando a dei contadini, oppressi dal molto lavoro, ai quali vuole evidenziare come anche nel contesto lavorativo, sussistendo il fondamento della pace interiore, sussiste la preghiera stessa.
La pace interiore conduce, inoltre, a non pensare ai propri peccati nell’atto del pregare. La coscienza del peccato “attuale”, infatti – non quella dell’essere dei peccatori in senso lato – rischia di agitare lo spirito, scosso dal pensiero del peccato, e di creare una disarmonia nella preghiera. L’abbandono nelle mani di Dio, che la preghiera presuppone, consegna a Dio anche l’inquietudine del peccato nell’ottenimento della pace.
La fede nella potenza della preghiera
Nel contesto dei suoi insegnamenti sulla preghiera dati alla Valtorta per il tramite della sua opera, vi è quello di credere con tutto se stesso nella efficacia che – ponendosi con le giuste condizioni spirituali dinanzi a Dio – la preghiera ottiene, anche se secondo forme, modi e tempi che solo Dio conosce, ciò che di santo ad essa è intrinseco. La preghiera, in tal senso, non è mai vana, né inutile. Gesù lo afferma chiaramente, ci vuole “fede nella potenza della preghiera” (Ivi, Volume 1, Capitolo 46,5). Ciò non deve, tuttavia, essere utilizzato nella prospettiva di un accomodamento umano, tipico di chi prega solo quando ha bisogno di qualcosa di urgente (e solitamente di natura materiale) e “pretende” che “immediatamente” gli sia dato ciò che domanda.
Sebbene, infatti, nell’opera della Valtorta Gesù esorti a chiedere senza riserve a Dio ciò che si ritiene necessario (cosa che accade anche nei Vangeli, cf. il “chiedete e vi sarà dato” di Mt 7,7-8 e Lc 11,9-13), al contempo esorta a non cadere nell’atto di “tentare Dio”, pretendendo un immediato riscontro (e su basi soltanto umane e personali) di ciò che si è chiesto.
Aver fede nella preghiera, secondo l’insegnamento che Gesù ci trasmette attraverso l’opera valtortiana, si inserisce coerentemente nel più grande insegnamento che egli stesso ci lascia nell’opera[1] e sul quale torneremo più avanti, ma che qui sottolineiamo nella sua sostanza obbedienziale, da un lato, e nella sua forma fiduciale, dall’altro. Cosa significa, tutto ciò?
Significa che se Gesù ci esorta a “chiedere a Dio”, nella preghiera, ciò di cui abbiamo bisogno, al contempo ci insegna a deporre ogni attesa nella nostra condizione filiale rispetto al Padre, che sa di che cosa (veramente) abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo (cf. Mt 6,8). La sostanza da noi definita obbedienziale della fede nella potenza della preghiera, si manifesta nella non fuoriuscita da questo insegnamento, “obbedendo” alla speranza che il Padre intervenga provvido e sollecito a colmare quelle nostre necessità che egli conosce prima e meglio di noi. La forma fiduciale si manifesta, invece, nel riposo su quella conoscenza di Dio che ci garantisce, nello spirito, la consapevolezza del suo amore per noi, che lo induce ad arricchirci costantemente dei suoi doni, fra cui fondamentale e infinito è quello del suo perdono: “La preghiera fidente può mutare un castigo in benedizione”, afferma Gesù nell’opera della Valtorta (L’Evangelo, Volume 5, Capitolo 352,11).
La consapevolezza di come Dio ascolti la nostra preghiera e ne assecondi il santo proposito, ci aiuta a trasformare la nostra vita in un continuo, dolce e mai egoistico colloquio con Dio, come Gesù stesso ci insegna: “La preghiera perseverante apre il Cielo, e la fede salva l’anima in qual che sia il modo che la preghiera sia ascoltata ed esaudita” (Ivi, Volume 8, Capitolo 505,6).
La preghiera come acquisizione e perfezionamento della conoscenza di Dio
Nell’opera citata in precedenza nella nota n°1, cioè “La fede languente”[2], si è descritta la fede – insegnata da Gesù alla Valtorta – come “possibilità di salvezza” che si realizza in tre forme distinte (quelle della conoscenza, della fiducia e dell’adesione), ma tenute insieme da una sostanza comune, ossia l’obbedienza. Qui, tuttavia, ci interessa comprendere la prima di queste forme citate, ossia quella della conoscenza di Dio. Se essa, infatti – al di là degli infiniti studi su questo tema – è anzitutto un dono di Dio che parte da un suo libero disegno, siamo tuttavia noi che questo dono dobbiamo accogliere e fare fruttificare. La preghiera è il veicolo fondamentale di questa acquisizione. Gesù dice alla Valtorta, per esempio: “Prima o poi dovrete riconoscere questa Bontà intelligente che vi cura” (Quaderni del 1943, X, Capitolo 190, 29 novembre 1943). Se preghiamo con umiltà e costanza, la conoscenza di Dio si svela anche al nostro intelletto e al nostro cuore. Conoscere Dio, infatti, è salvezza eterna, poiché si comprende – e nella comprensione si aderisce – chi è Dio, l’infinità del suo amore, la sua chiamata per ognuno di noi affinché, in eterno, abbiamo parte con lui[3]. In questo senso, la preghiera dispone ed alimenta, già in questa vita, tale riconoscimento di Dio, nel senso qui di una oggettivazione della sua esistenza, del suo amore e, ancora di più, della sua presenza accanto a ognuno di noi. Per questo motivo l’angelo Azaria (che si è rivelato alla Valtorta come il suo angelo custode) ci insegna a pregare, nello sviluppo della nostra fede, dicendo: “Ti prego perché si compia ciò che è tua gloria e ciò che può essere santificazione dei fratelli” (Libro di Azaria, Capitolo 15, 2 giugno 1946).
Pregare perché Dio sia glorificato, infatti, è pregare che egli si manifesti nella sua essenza di amore: ciò implica domandare che Dio sia conosciuto e, per mezzo di questa sua conoscenza, l’uomo sia santificato.
Il metodo del Ciprel
Con una frase molto semplice, possiamo dire che il metodo di preghiera del Ciprel è l’illuminazione della coscienza mediante il colloquio continuo dello spirito con Dio. Tre termini vengono qui necessariamente a dover essere intesi.
Il primo termine è quello di illuminazione. Nell’opera già citata in precedenza, “La fede languente”, si è descritta l’illuminazione come la terza forma della conoscenza di Dio (la prima è quella della Scrittura, la seconda è quella della natura). A questa forma di conoscenza, si è associata l’esperienza dei Magi, come testimoniata dalla Valtorta. Essi, “illuminati” dalla stella, si sono fidati di Dio e, avendolo previamente conosciuto nelle loro conoscenze personali, lo hanno poi adorato quando ne videro l’incarnazione nel Figlio.
Nel nostro orientamento spirituale, proponiamo un simile percorso: dal nostro cuore alla culla di Betlemme, da quest’ultima al Calvario e da qui, infine, al monte dell’ascensione, seguendo l’illuminazione della nostra “stella” (la preghiera), che ci orienta alla conoscenza di Dio mediante la Sacra Scrittura e la contemplazione della natura.
Il secondo termine è un aggettivo, ossia quello di “continuo”. Esso viene impiegato già nel Nuovo Testamento per definire l’inesauribilità della voce orante che si deve elevare a Dio. In Maria Valtorta, tale necessità di una preghiera “continua” ha il senso di una risposta, più che di una proposta, alla “continuità” con cui Dio ama l’uomo e gli concede (spesso senza che questi lo veda e lo ringrazi) i benefici della sua grazia.
Il terzo termine è, infine, quello stesso di “spirito”. La Valtorta ha delle specificazioni molto attente e puntuali su questo termine, il cui senso nel linguaggio contemporaneo è spesso confuso e talvolta emarginato. Lo spirito è creato direttamente da Dio, è la “parte” (cf. qui la nota n° 3) eletta dell’anima, nella quale dimora la somiglianza con Dio. Come dice Gesù, “la somiglianza con Dio […] è in questo spirito, atomo dell’infinito Spirito, che rinchiuso in angusta e precaria carcere attende e anela di ricongiungersi alla sua Sorgente e condividere con Essa libertà, gioia, pace, luce, amore, eternità” (Quaderni del 1943, X, Capitolo 190, 29 novembre 1943).
In tal senso, la preghiera è vita dello spirito, poiché lo illumina e ne rende feconda la somiglianza con Dio.
Tornando, così, all’iniziale definizione del nostro metodo di preghiera (l’illuminazione della coscienza mediante il colloquio continuo dello spirito con Dio), ci si propone di intraprendere degli itinerari spirituali, in cui, nel confronto comunitario ed individuale, si possa percepire questa fondamentale illuminazione di coscienza e, per progressioni continue prodotte dalla grazia, si possa raggiungere un livello sempre più trasformante lo spirito nella sua unione di somiglianza con Dio.
Dice infatti Gesù a Maria Valtorta: “Occorre tendere ad essa con tutte le vostre forze, con tutte le vostre generosità. Senza voltarsi indietro a guardare ciò che si lascia. Senza fermarsi mai. Senza stancarsi. Il premio giustifica l’eroismo, perché il premio è tuffarsi nel godimento dell’Amore, avere perciò Dio come lo avrete in Cielo” (Ivi). Con queste parole la “continuità”, sopra menzionata come caratterizzante il nostro metodo di preghiera, viene sviscerata nella sua significazione, che più che non temporale, è di tipo volitivo: “Non stancarsi mai”.
Come attualizzare la continuità della preghiera
Nel Nuovo Testamento, sia nei Vangeli che, in modo speciale, nelle lettere di Paolo, quando si parla della necessità della preghiera, viene evocata insieme la necessità della sua continuità. La Valtorta riprende questa tematica e, mediante un approfondimento spirituale, ci aiuta sia a capire “perché” la preghiera debba essere “continua”, sia “come”, a livello pratico, essa si possa attualizzare, nella concretezza della nostra vita. Il Ciprel assume l’insegnamento valtortiano e lo propone come prassi metodica spirituale.
Dice, per esempio, Gesù alla Valtorta che la preghiera non è feconda unicamente nella forma estetica ed esteriore con cui uno prega, poiché, come abbiamo visto sopra citando quei contadini ammaestrati da Gesù, essa può raggiungere l’intimità divina anche nel contesto lavorativo ordinario. La continuità è infatti dello spirito in colloquio con Dio, non della forma esteriore: si può, quindi, mantenere viva la continuità della preghiera anche se l’oggettività esistenziale “interrompe”, con le sue necessità ordinarie (lavoro, famiglia, ecc.) una determinata istanza oratoria. Ciò non implica che, inversamente, si possa rinunciare, a motivo di qualsiasi esigenza della vita, a dei momenti specifici in cui ci si isola dalle vicende esterne e ci si decide per uno speciale investimento nella preghiera. La continuità si garantisce, quindi, solo riuscendo a mantenere viva la preghiera indipendentemente dall’attualità che uno sta vivendo, sia quella del caos nel mondo o quella di un isolamento spirituale. Anche la Madonna, parlando alla Valtorta, le confida come, al di là delle vicende e degli eventi concitati e dolorosi, non sia mai mancata in lei, e nel suo sposo Giuseppe, la disposizione alla preghiera, senza che nulla potesse condizionare la volontà dello spirito al colloquio con il Signore.
È dunque l’aspetto “volitivo” quello caratterizzante il metodo spirituale del Ciprel: suscitare una volontà di continuità di comunione con Dio (al di là dei contesti “attuali”, sempre diversi), mediante una preghiera che, se illuminata, non risente in alcun modo del contesto in cui essa viene proferita, essendo lo spirito soggettivo “continuamente” presso Dio.
In tal senso, il Ciprel, di valtortiana ispirazione, si può definire, senza accuse di controsenso, una dimora di preghiera al contempo collettiva e individuale. Se si è detto, infatti, che la continuità della preghiera – che Gesù stesso ci domanda – viene generata dall’unione dell’io con Dio, la sua concretizzazione è dunque data dal superamento dell’opposizione fra individuo e collettività, fra vita soggettiva e comunitaria.
Per questo, nel suo proposito metodico che abbiamo definito “illuminativo”, il Ciprel da un lato organizza degli incontri di preghiera e di meditazione “comunitari”, ma dall’altro pone le basi affinché a livello individuale il soggetto permanga ovunque, anche al di fuori del Ciprel, in una illuminata e continuativa condizione di preghiera, avente cioè l’anima orante in ogni contesto della sua soggettiva esistenza. Ciò si collega con quello che Gesù, in un passo valtortiano, dice ai discepoli relativamente al tempo in cui si troveranno da soli fra i pagani: suscitare il loro stupore nel vedere in che modo, ovunque, vivano la loro fede, in modo da convertire, prima o dopo, i loro cuori.
La centralità del cuore
“Centro” è un titolo con cui qualifichiamo il Ciprel non tanto dal punto di vista dell’organizzazione, quanto piuttosto da quello del “cuore”, da cui la preghiera sorge e si diffonde in tutta la persona e, mediante la persona, nel mondo. Gesù dice per esempio alla Valtorta che lì dove il cuore è, lì convergono l’intelletto, la parola, lo sguardo, l’azione (cf. L’Evangelo come mi è stato rivelato, Volume 3, Capitolo 172,5). Il cuore è il centro della persona nel suo riconoscersi creatura bisognosa del Padre. L’illuminazione che al Ciprel si cerca di infondere nel soggetto, è l’importanza di una preghiera che sorga dal cuore: in tal modo, la continuità di cui sopra si è parlato è in parte già garantita, poiché ciò che dimora nel cuore, accompagna il soggetto ovunque egli vada. L’origine “dal cuore” della preghiera è attestazione, inoltre, della sua sincerità. Chi prega al Ciprel, secondo l’insegnamento della Valtorta, prega Dio, unicamente al fine di ottenerne la compagnia spirituale, il confronto personale, la fusione interiore. Non si cercano, cioè, altri fini umani per l’ottenimento dei quali, talvolta, la preghiera è un puro mezzo. Gesù dice: “Lasciate ai superbi e ai falsi questa povera gloria! Lasciate ai superbi e ai falsi questa effimera ricompensa” (Ivi, 172,4). Noi dobbiamo ottenere che la preghiera che noi stessi pronunciamo abbia il linguaggio del cuore, l’ispirazione dal cuore, l’origine nel cuore. In ambito teologico, nei secoli, si è spesso dibattuto sul modo ebraico (per alcuni oggi superato) di intendere questa centralità del cuore; alcuni hanno trasferito all’intelletto (nel senso dell’attività razionale) tale primato; altri lo hanno posto in seno alla volontà (nella capacità di scelta e di decisione). Al Ciprel, tuttavia, si ritorna alla semplicità del cuore, senza inseguire le dicotomie prodotte dai pensamenti teologici. In tal senso, l’illuminazione si dirà ottenuta, almeno nella sua insipienza spirituale, quando il soggetto avrà iniziato a pregare – come dice Gesù – “per impulso del cuore”: “È la prima ed essenziale qualità” (Ivi.)
L’attività spirituale e didattica
- I momenti fissi
Al di là dei luoghi comuni in ambito cattolico (per cui ad esempio un pescatore poco istruito può santificarsi più di un dotto scriba, ecc.), Gesù ha lasciato a Maria Valtorta – e quest’ultima l’ha testimoniato nella sua vita personale – un insegnamento specifico sul rapporto tra la fede dei semplici e la fede dei dotti, come pure tra fede devozionistica e fede teologica. In linea di principio, alcuni “idealismi” attribuiti a Gesù, su tali questioni, si devono purificare da determinati (e spesso voluti) errori di interpretazione. Se è vero, infatti, che nei messaggi e nelle visioni di Maria Valtorta viene molto stimata da Gesù la fede semplice (ma autentica) di persone senza una particolare cultura, è anche vero che Gesù esorta, senza però che ciò divenga razionalismo superbo, ad approfondire, come possibile, le proprie conoscenze bibliche e religiose, non per un fatto culturale, ma per un ausilio alla santificazione. Più volte, nell’opera della Valtorta, si evidenzia ad esempio quanto poco si leggano i Vangeli. È dalla lettura “viva” che poi nascono gli studi, le meditazioni e i sussidi alla conoscenza. Gesù ci tiene, tuttavia, che tutto ciò – che è utilissimo alla santificazione, tanto che in un discorso alla Valtorta le dice che leggere i Vangeli è già santificazione, e parlare di Gesù è già santificazione – ebbene, avvenga, anche qui, secondo la semplicità del cuore e non secondo la vanità del mondo. In tal senso, oltre che mettere a disposizione dei presenti i testi del Vangelo e alcuni sussidi alla lettura, il Ciprel organizza degli appuntamenti di meditazione “con il cuore” dei Vangeli, alla luce anche della preziosa ermeneutica valtortiana, in modo tale che la divina Parola possa interpellare il cuore e, dal cuore di ognuno (a suo modo) sorgere un’accoglienza fervente della sua comunicazione.
Questo momento “fisso” dell’attività del Ciprel, tuttavia, va inteso come realtà orante, cioè come contenuto della preghiera stessa, non al modo di un corso di teologia. La semplicità è il territorio più fertile, riteniamo, per una spiritualizzazione della coscienza, la quale non ha in se stessa un legame immediato con la teologia intesa secondo il linguaggio contemporaneo.
La preghiera del rosario è il secondo momento “fisso” (non in senso cronologico) dell’attività del Ciprel, il rosario nel quale ognuno, secondo il linguaggio del suo cuore, interviene armonicamente nell’esposizione delle Ave Maria, affinché in lui sorga l’illuminazione dello spirito e possa testimoniarla agli altri. Nell’opera di Maria Valtorta sono molti gli appelli che Gesù fa (per prima alla sua veggente) relativamente all’importanza della contemplazione viva del mistero della sua partecipazione alla nostra storia umana. In una circostanza speciale è la stessa Madonna a chiedere alla Valtorta (già stremata per le malattie e la stanchezza) l’ulteriore recita dei misteri del dolore, a motivo di alcuni eventi dolorosi in atto nel mondo. E Gesù non dispensa mai il suo “piccolo Giovanni” dall’efficacissima recita di ulteriori novene, offerte per il bene dei fratelli.
Il rosario comunitario, emergente “dal cuore” (eventualmente, a seconda dei casi, anche la recita di qualche speciale novena) è parte integrante della spiritualità del Ciprel, depurandone la forma e il metodo della recitazione da un’idea (dal sottile sottofondo pagano) di una preghiera monotona o addirittura superstiziosa. Dice a riguardo la Madonna: “Ti ho dato il 5 la vista intellettiva di ciò che è un Rosario ben detto: pioggia di rose sul mondo. Ad ogni Ave che un’anima amante dice con amore e con fede, io lascio cadere una grazia. Dove? Dappertutto: sui giusti a farli più giusti, sui peccatori per ravvederli. Quante! Quante grazie piovono per le Ave del Rosario!” (Quaderni dal 1945 al 1950, CXVI, Capitolo 606, 8 maggio 1947). Il rosario, al Ciprel, intende attuare questa promessa della Vergine Maria.
Vi è poi un terzo momento, l’ultimo di quelli da noi definiti “fissi”, che costituisce l’attività di preghiera del Ciprel. Se, infatti, il fine fondamentale della nostra attività, come abbiamo detto sopra, è quello di una illuminazione della coscienza per un continuo colloquio con Dio, è chiaro che questa coscienza deve essere previamente purificata da ciò che la priva della coabitazione con la grazia, di cui l’illuminazione auspicata non è che un segno: il peccato. Ovviamente, non si tratta qui di procedere con una confessione sacramentale, la cui competenza è riservata ai sacerdoti. Piuttosto, si tratta di una fase della preghiera comune nella quale, con il cuore contrito, si medita su se stessi e si offrono al Salvatore (in vista della confessione) tutte le piccole o grandi trasgressioni rispetto al suo amore. Il Ciprel offre degli spunti testuali su questo tema, in modo che, mediante un conforto biblico o testuale, il soggetto sia confortato nella riesamina della sua coscienza.
- I momenti “accidentali”
Essendo pensati come aventi luogo mensilmente in Chiesa (e con cadenza concordata anche negli ambienti della Casa di Miriam), gli incontri “comunitari” del Ciprel[4] possono prospettare alcuni incontri speciali di adorazione eucaristica e altri di catechesi su determinati argomenti da parte di qualche sacerdote invitato per l’occasione[5].
Sull’adorazione eucaristica, Gesù ha detto molte cose alla Valtorta, come pure l’angelo Azaria. Ad esempio, Gesù ha rivelato come i pastori della Natività siano stati i primi adoratori del Corpo del Signore. Azaria ha rivelato con quanta indicibile partecipazione gli angeli tutti adorino il Santissimo Sacramento e in modo speciale l’Eucaristia, sebbene essi, ovviamente, non possano assumerla. Il fine del Ciprel, in questo ambito, è quello di attuare le parole di Gesù alla Valtorta, quando le dice: “Infinite sono le Chiese dove sono solo. Vieni con il tuo spirito in esse. Supplisci alle altrui mancanze d’amore. Impara da me a dire: Ho ardentemente desiderato. Ho ardentemente desiderato di venire a te, Gesù che stai tutto solo su tanti altari, per dirti che ti amo con tutta me stessa. Ho ardentemente desiderato di vederti, o mio eucaristico Sole” (Quaderni del 1943, VIII, Capitolo 158, 27 ottobre 1943). Gesù si è lamentato di come egli sia lasciato spesso solo nei tabernacoli delle Chiese. Ha detto ancora, a riguardo di ciò: “Troppo poco sono adorato dai cristiani, dai cavillatori che per adorarmi hanno bisogno di più di un apparato. Oh! ma amatemi solo per forza d’amore! Vedetemi e credetemi solo per forza di fede!” (Ivi).
Seguendo l’insegnamento della Valtorta e i parametri metodologici sopra esposti, il Ciprel intende da un lato compensare la carenza espressa da Gesù, dall’altro ottenere, nell’umiltà e nella preghiera adorante, quella grazia dell’illuminazione della coscienza che ci porta a riconoscere Gesù Cristo come degno di adorazione e di lode.
Un altro tipo di attività “accidentale” proposta dal Ciprel (oltre a quelle che qui non sono elencate in quanto contingenti alle singole situazioni degli incontri), è quella del confronto e della “distribuzione” di testualità sacre e, specificatamente, di estratti testuali valtortiani, al fine di trarre, dalla conoscenza delle vite dei santi o dei mistici, o dello stesso Magistero in alcuni suoi documenti, un maggiore arricchimento dello spirito.
Le opere di misericordia corporale, veicolo per la elevazione dello spirito
Il Ciprel si propone – in modo coerente alle sue possibilità – una diffusione dello spirito di concretezza nella adesione alle opere di misericordia corporale. Gesù ha insegnato come queste ultime costituiscano un basamento previo a quelle dello spirito. Come sappiamo dalla stessa testimonianza della Valtorta, Gesù girava, ovunque andasse, con una “borsa per i poveri” e, in ogni città in cui entrasse, il suo primo interesse era per i malati (nello spirito) e i poveri. La quantità di miracoli e di guarigioni, ma anche di beneficenze, di aiuti, di consolazioni e di atti di amore nei riguardi dei malati, dei bisognosi e dei sofferenti, è immensa da parte di Gesù. Ai suoi discepoli, e a tutti noi, Gesù domanda il medesimo comportamento, senza perderci in valutazioni pregiudiziali o egoistiche rispetto a ciò.
Il Ciprel intende, sempre nella prospettiva della illuminazione della coscienza, risvegliare lo spirito cristiano con la virtù concreta del servizio e dell’aiuto a chi soffre (secondo le possibilità di ognuno), sapendo che è da qui che “il cuore” – di cui si è parlato in precedenza – costruisce la preghiera più autentica, quella di un amore oggettivamente vissuto e che è veicolo per una ascesa spirituale ai beni celesti.
Illuminazione e sacrificio
Al “centro” (nel senso di questa parola che sopra abbiamo evidenziato) dell’attività del Ciprel, si è detto che sussiste la ricerca dell’illuminazione dello spirito (grazia) che conduca il soggetto ad un “continuo” colloquio con Dio. Tale illuminazione, tuttavia, conosce un momento significativo di espressione quando è associata all’esperienza della sofferenza. Se il Ciprel, infatti (alla luce dell’insegnamento valtortiano) si adopera, da un lato, nella concretizzazione delle opere di misericordia corporale, dall’altro, tanto di più (e ancora con il sostegno ispiratore di Maria Valtorta) si impegna nella conoscenza e nell’accettazione di quella illuminazione che ci rivela come, nella sofferenza, si vive in modo sublime l’amore di Cristo e perciò essa non la si deve – come accade spesso – con ogni mezzo esorcizzare come nemica dell’uomo.
In un passo dell’Evangelo come mi è stato rivelato, Gesù dice al suo diletto Giovanni: “Più si soffre e più si redime” (Volume 8, Capitolo 527,6, 8 novembre 1946). Queste parole, così semplici nella costruzione letteraria, sono tanto difficili da comprendere e soprattutto da accettare, per molti motivi. Innanzitutto, perché la sofferenza non piace a nessuno e sono pochissimi coloro che (lo diceva a suo modo già san Paolo) sono pronti a soffrire affinché a un altro venga del bene. In verità, tuttavia, vi è un secondo motivo, più profondo e teologicamente complesso del precedente, che in molte coscienze rende incomprensibili e inaccettabili le parole di Gesù sul valore della sofferenza. Tale motivo si genera dal rifiuto o dall’incomprensione del significato di “redenzione”, sia di se stesso, sia degli altri. Persino in alcuni ambienti teologici il concetto di “redenzione” soffre i dolori del parto. E tuttavia, l’opera della Valtorta volge continuamente ad esso il suo sguardo, sia nel senso della redenzione operata da Gesù (che gli è costata l’acquisto a caro prezzo, cioè nel dolore assoluto) di noi stessi, sia nella corredenzione attuata da Maria, che le ha riservato la consacrazione a sofferenze terribili (e anch’esse accettate per noi), sia, ancora, la partecipazione a questo principio di redenzione che, cominciando dal giusto Giuseppe, sposo di Maria e fino ai giusti di ogni tempo, contribuisce, “nel dolore” a quell’oggettiva purificazione del cuore, alla liberazione dal peccato e all’annullamento delle sue conseguenze in ogni uomo disposto, nella fede, a tutto ciò. La sofferenza è la via illuminativa per eccellenza, poiché più di ogni altra, se vissuta “nel Signore”, accelera i tempi della purificazione e produce i frutti della redenzione.
La Valtorta ha vissuto in modo estremo questa partecipazione alla sofferenza, offrendosi come anima vittima per i peccatori “sponte sua”. Non certo a tutti, Gesù, chiede un simile investimento “nel dolore”: ciò nonostante, ci chiede di saper cogliere il valore redentivo che si nasconde dietro le piccole o grandi sofferenze che viviamo, per noi stessi e per gli altri, e che la fede ci insegna che non sfuggono mai in alcun modo allo sguardo di Gesù, ma anzi, gli risultano immensamente gradite quando sono offerte per la purificazione dal peccato. In tal senso, ciò che per la guarigione dalla sofferenza oggettiva dei malati e dei sofferenti che al Ciprel è proposto, non contrasta l’insegnamento teologico sul valore redentivo della sofferenza che, negli incontri di preghiera, viene meditato. Non vi è infatti in ciò alcuna contraddizione, dal momento che Gesù stesso (e la Valtorta lo insegna con esempi molteplici nella sua opera) – che ha guarito moltitudini di malati – è lo stesso che insegna l’immenso valore della sofferenza quando è accettata e offerta per espiare i propri o altrui peccati.
La spiritualizzazione della persona umana
Persona è un termine che, oltre che ai Tre della SS. Trinità (dopo molteplici studi sul tema), e oltre che alle creature angeliche, viene riferito all’uomo, anche se in un modo molto diverso che negli altri due casi suddetti. In un certo senso, il riconoscimento dell’uomo in quanto “persona”, con tutto ciò che consegue, è già un primo traguardo dell’amore, poiché riconosce in lui, e chiunque sia, una dignità e un valore che non possono mai essere violati, per nessuna ragione. Gesù, tuttavia, ci chiede ancora di più di questo semplice riconoscimento. La Valtorta lo evidenzia a più riprese nella sua opera. Gesù ci domanda già su questa terra la spiritualizzazione della persona umana. Ivi è un ulteriore principio di illuminazione della coscienza che il Ciprel, mediante la preghiera, cerca di approfondire. Vi è un dato previo da chiarire, in questa direzione. L’uomo, infatti, non è un puro spirito, come gli angeli (né, ovviamente, è spirito come le Persone divine). La persona, nel senso umano del termine, si attua anche mediante il corpo, che è reso vivo dall’anima che è in lui. Lo spirito umano è la parte eletta dell’anima, in cui, come si è visto sopra, vive e feconda la somiglianza con Dio, che è il parametro per la nostra vera gioia. Gesù non ci chiede – non potrebbe chiedercelo, essendo il corpo voluto da Dio – di dimenticarci di avere un corpo. Egli provvede, anzi, nella giusta misura, alle necessità corporali (come ci attesta Matteo 6,25ss.). Ci promette inoltre la risurrezione del corpo, sul modello della sua stessa risurrezione. Ciò che invece Gesù vuole che noi rimuoviamo da noi stessi (e dunque dalla nostra persona), è la “carnalità”, intesa qui come dominio dispotico e oscurante della carne sullo spirito. “È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla”, dice Gesù in Gv 6,63. La Valtorta echeggia questo insegnamento di Gesù con molteplici richiami alla necessità del primato dello spirito, nella persona, rispetto al corpo, inteso qui nel senso “carnale” del termine.
“Io vi voglio spirituali”, ad esempio, è un’esortazione che Gesù, nell’opera di Maria Valtorta, destina ai suoi Apostoli, legati “alla carne” secondo l’intemperanza, il pregiudizio, l’ira, la focosità, i sensi. E tuttavia questa sua esortazione è giunta a tutti i discepoli della prima ora, accomunati ognuno a suo modo dalla medesima carnalità, e persino a tutti quelli che poi non lo hanno seguito, né più ascoltato. E giunge a noi, oggi.
La Valtorta non si dispensa da una solo apparente esagerazione: “Siate come serafini”. Gesù, cioè, ci esorta a ricordarci della natura spirituale dell’amore, di cui, nel caso umano, la carne è un sacramento. Il Ciprel nella preghiera si impegna al conseguimento di questa condizione “angelica” dello spirito, che nell’uomo riposa nel corpo e arde d’amore per Dio.
Dio al primo posto, nel pensiero e nell’atto
L’illuminazione di coscienza secondo la grazia, lo si è già evidenziato a più riprese, è il fine spirituale delle attività, delle preghiere e delle meditazioni del Ciprel. Maria Valtorta ci agevola il perseguimento di questo fine con la sua preziosissima testimonianza, che se già i Vangeli prospettano, viene per il suo tramite purificata da interpretazioni riduttive o peggio fuorvianti.
Sin dal principio dell’opera valtortiana è Gesù stesso a testimoniare, con i suoi gesti, le sue parole, i suoi atti, come sia il volere del Padre a dover possedere l’assoluto primato sul volere umano. Dice ad esempio Gesù ai suoi Apostoli: “Vogliate soprattutto bene alla volontà di Dio” (L’Evangelo come mi è stato rivelato, Volume 3, Capitolo 176,1, 1giugno 1945).
Queste parole di Gesù non vanno intese come un “ossessivo” richiamo al primato della volontà di Dio sulla nostra, né superficialmente accolte senza un concreto riverbero nella nostra vita.
L’illuminazione della coscienza si dilata tanto più uno capisce che l’ossequio alla volontà di Dio non è un puro assenso dell’intelletto che poi rimane, ciò nonostante, ancorato al primato delle cose umane su Dio.
Piuttosto, esso consiste in uno slancio, in un abbandono totale alla volontà di Dio, poiché la si riconosce senza riserve come una volontà giusta, che ama, che libera e che salva dall’errore la volontà umana. Non ci può essere falsità in questa dichiarazione di adesione a Dio, poiché egli conosce i suoi figli e legge l’eventuale inganno del cuore. Nell’opera valtortiana si moltiplicano gli esempi di smascheramenti che Gesù effettua, nei cuori umani, in riferimento a quell’ipocrita – perché non realmente sussistente e solamente esteriore – adesione a ciò che Dio vuole. La verità della vita, tuttavia, come pure la salvezza eterna, non si possono conseguire mantenendo la volontà umana in posizione egemone rispetto alla volontà divina. Gesù ce lo ha insegnato, per esempio, nella preghiera del Padre nostro, quando ci esorta a dire: “Sia fatta la tua volontà”. Sono le stesse parole che Gesù pronuncia nel Getsemani, dinanzi alla sua imminente passione. Sono le stesse parole, ancora, che Gesù ha trasformato in gesti e opere concrete nella sua vita pubblica sino alla fine, combattendo tutte le forze ostili che si opponevano al compimento della volontà del Padre nella sua vita. E se sulla croce il Figlio ha vissuto l’abbandono del Padre (che la Valtorta intende come il raggiungimento della perfezione del supplizio), non per questo il Figlio ha smesso di invocarlo e di consegnare se stesso alla sua volontà.
Non è sempre facile questo percorso integrale di consegna totale del primato della propria vita alla volontà del Padre, insidiati come siamo da molteplici forme di ripudio e di diniego di essa. Il Ciprel, nella sua ricerca di illuminazione della coscienza (con il conforto della testimonianza valtortiana), induce lo spirito a meditare e a cercare di rafforzarsi nella coscienza della sua totale dipendenza, in ogni situazione della vita, dalla volontà di Dio.
Gli incontri al Ciprel
Si è detto che mensilmente il Ciprel prega in Chiesa, ma che la sua attività si svolge come luogo fondamentale negli ambienti della Casa di Miriam[6]. Ivi si possono ricevere informazioni, partecipare alle iniziative qui organizzate e consultare i testi, in specie di o su Maria Valtorta, nonché le Bibbie e i Vangeli resi disponibili per il tramite delle Edizioni La Casa di Miriam.
Tutti i gruppi che vorranno aggregarsi al Ciprel, in Italia o nel mondo, devono segnalare la loro adesione e la loro applicazione di quanto disposto nel presente libretto costitutivo e aggiungere al nome “Ciprel” quello della località in cui operano.
Gli incontri in Chiesa, una volta al mese, hanno la durata di un’ora e, previo consenso sacerdotale, sono diretti totalmente dal personale laicale preposto a ciò (in ciò che ai laici è consentito e che non intralcia l’ufficio sacerdotale).
Quando gli incontri avvengono, invece, negli ambienti della Casa di Miriam, essi sono diretti dal personale del gruppo La Casa di Miriam e, l’eventuale invito di sacerdoti, non li vincola alla conduzione degli incontri. Il Ciprel intende, infatti, nel pieno rispetto del sacerdozio, proporre una spiritualità cattolica laicale.
Appendice
La fede cattolica secondo l’idea valtortiana: schemi e spiegazioni per capire la fede
Nel nostro testo, già citato in precedenza, intitolato “La fede languente”, abbiamo elaborato la proposta di una definizione teologica della fede, alla luce della integralità di ciò che la Valtorta ha scritto. Questo per rendere l’idea di una solidità anche “teologica” dell’opera in oggetto. Questa definizione – cui segue lo schema visivo – è la seguente:
“La fede è possibilità di salvezza nella triniforme unità dell’obbedienza”.
Volendo spiegare con semplicità questa definizione – cosa che rispecchia lo spirito metodico del Ciprel – possiamo dire che “possibilità” di salvezza, per la fede, significa che Dio non la impone, ma la propone nel suo Figlio. “Triniforme” significa, come si può vedere nello schema più avanti, che sono tre le forme nelle quali questa fede viene proposta: la conoscenza, la fiducia e l’adesione a Dio. La conoscenza è ciò per cui Dio si rivela al nostro intelletto, mediante tre ulteriori forme: la Scrittura, la natura e l’illuminazione. Proprio questa illuminazione, nella preghiera, è il quid differenziale del Ciprel: ottenere la grazia di un continuo colloquio con Dio per tutta l’esistenza terrena, in ogni contesto nel quale uno venga quotidianamente a trovarsi. Esiste, in tal senso, una via unitiva, cioè una sostanza che tiene insieme le tre forme sopra elencate: l’obbedienza. La Valtorta non si risparmia in nulla nella valorizzazione di essa come la sostanza onnipresente in tutte le virtù e che fondamenta la fede stessa nella sua “possibilità” attuativa.
Il Ciprel è una realtà spirituale che opera sotto la direzione organizzativa delle Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam Torino. Il suo fondatore è Francesco G. Silletta, teologo ed editor
Copyright Edizioni e Libreria Cattolica La Casa di Miriam
Piazza del Monastero 3 – 10146 – Torino
Tel. 3405892741
www.lacasadimiriam.altervista.org
Estratto esemplificativo da una meditazione al Ciprel: “A te che corri dove ti percepisci amato”
“[…] Gesù, io so che tu ci sei, e ci sei come Signore di tutte le cose, e anche se tutto dovesse far sembrare lontana o persino inesistente la tua presenza, tu ci sei, e tutto domini e governi. La fede si erga sopra le iniquità del mondo, al di là delle sembianze che esso assume, e continui a produrre una rinnovata e ferma, indissolubile certezza, nel nostro cuore, che Gesù Cristo è Signore della storia, e che il suo sguardo è onnipotente e onnisciente su ogni singola attività del creato. Questa fede in te, Gesù, che talvolta necessita di un eroismo speciale per non essere avvolta nei dubbi della vita, sia il nostro continuo atto d’amore per te, che ti sei consegnato a noi, affinché divenissimo tuoi mediante il tuo sacrificio. Non lasciarci mai, dunque, senza la fede in te, o con una fede soltanto parvente, soltanto intuitiva, soltanto esteriore: tutto ciò che operiamo in questa esistenza abbia la mozione da questa fede in te e sia orientato e finalizzato alla fede in te. Dove infatti tu ti percepisci da noi creduto, vivente nella nostra fede, tu giungi glorioso e potente, e ci consoli e liberi da ogni male, secondo il tempo e il modo della tua sapienza. Ora noi ti chiediamo che per mezzo della fede in te, tutto ciò che siamo divenga una cosa sola con te, senza più nessuna distanza temporale, senza più che l’ambiente o il luogo terreno in cui siamo ci dividano o ci separino da te, poiché tu spezzi ogni distanza e colmi ogni vuoto, trascendi il tempo e non hai limiti di estensione. Vieni ad abitare in noi, Gesù, in modo speciale laddove siamo più orfani di pace e di serenità, dove in noi si alimentano sospetti e inquietudini, e diviene feroce la paura. Abbiamo bisogno di te per poter vivere: tolto te, è la vita stessa che ci viene tolta, e questo ce lo dice la fede in te. Salvaci dunque da ogni tribolazione spirituale, poiché sappiamo che tutto passa via veloce, e viene l’ora anche per noi, in un momento qualsiasi, di venire al tuo cospetto, chiamati da te a lasciare questo mondo e a mostrarti l’esito della nostra esistenza. Sii buono con noi, Gesù, pur essendo noi peccatori e miserabili nel darti l’amore e la lode che meriti. Salvaci dalle rovine della nostra esistenza, per la fede che illumina il nostro cuore, affinché da oggi diveniamo sempre più lieti di essere cristiani, segnati come figli di Dio nel mondo e operanti per la testimonianza della tua salvezza. Sii benedetto, Gesù. […]” *** Testo di F.G. Silletta
Lettura di Mt 6,9-15:
9 Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
10 venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
12 e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
13 e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
14 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 15 ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Recita del S. Rosario insieme
Lettura meditata di un brano di Maria Valtorta[7]
“[…] Solo il mio amore poteva dirvi: Dite ‘Padre nostro’. Con questa espressione vi ho investiti pubblicamente del titolo sublime di figli dell’Altissimo e di fratelli miei. Se qualcuno, schiacciato dalla considerazione della sua nullità umana, può dubitare di essere figlio di Dio, creato a sua immagine e somiglianza, pensando a questa mia parola non può più dubitare.
Il Verbo di Dio non erra e non mente. E il Verbo vi dice: Dite ‘Padre nostro’[…]”.
(Quaderni del 1943, Capitolo 51, 7 luglio 1943)
Silenzio e preghiera personale
Considerazioni e brevi riflessioni condivise
Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
Conclusione:
“Ti benediciamo, Gesù, poiché ci hai dato l’occasione di pregare insieme, glorificando il tuo nome. Ti siano gradite le nostre intenzioni e permettici di amarti sempre più. Amen”.
L’effetto imitativo e santificante dell’economia valtortiana
L’istituzione di un nuovo centro di preghiera, fondato sui principi testuali, teologici e spirituali dell’opera di Maria Valtorta, è la conseguenza di quello spirito di conversione, di purificazione e di testimonianza evangelica che, prima ancora che dall’idea del fondatore, sorge dall’opera stessa, quale trasmettitrice di un principio imitativo nell’annuncio del Vangelo, nella vita di preghiera e nella stessa conversione del cuore.
Maria Valtorta, in tal senso, è un vitale principio di adesione al Vangelo di Gesù Cristo, poiché oltre che illuminarne il senso, i dettagli, i contenuti, le sfumature e molti altri aspetti, colpisce il cuore nella sua volontà di adesione all’insegnamento di Cristo, di purificazione dal peccato, di testimonianza dell’amore infinito di Dio, che non lo ha trattenuto dall’inviarci suo Figlio, in una carne umana, affinché fossimo salvati. Noi siamo figli dell’Amore e, riconoscendoci tali, ci sentiamo chiamati a moltiplicare – mediante la preghiera, la condivisione e la conoscenza – questa stessa filiazione, affinché molte anime possano avvicinarsi o riavvicinarsi alla fede cattolica.
Non un principio “docente” sta alla base del nostro centro, ma un principio “illuminante” da cui per primi noi siamo stati illuminati, mediante l’incontro con Maria Valtorta e la sua opera.
In tal senso, cerchiamo unicamente di trasformare la nostra vita sulla terra con il principio della “reciprocità della trasformazione” che la Valtorta ci insegna.
Nei suoi testi, ad esempio, alcuni personaggi hanno conosciuto e amato Gesù Cristo, trasformando se stessi, unicamente mediante degli altri personaggi coadiuvanti la loro trasformazione. Pensiamo per esempio a Giovanni di Endor, a Marziam (divenuto poi discepolo di san Pietro dopo l’ascensione di Gesù), o ad Anastasica o a Cleofa di Emmaus, o ancora agli stessi Simone e Giuseppe, due dei quattro “fratelli” del Signore. Tutti personaggi trasformati nel tempo – nella fede in Cristo – da dei conduttori di trasformazione, ossia altri personaggi che, prima di loro, hanno vissuto la medesima trasformazione, divenendo poi tutti dei discepoli di Gesù.
Il nostro centro segue la stessa ispirazione trasformatrice. Non maestri, ma testimoni di una conversione possibile, in qualunque momento e situazione della vita, anche in seno alla laicità.
La spiritualità del Ciprel
(Centro Internazionale di Preghiera Laicale)
(Dall’interno):
“Centro” è un titolo con cui qualifichiamo il Ciprel non tanto dal punto di vista dell’organizzazione, quanto piuttosto da quello del “cuore”, da cui la preghiera sorge e si diffonde in tutta la persona e, mediante la persona, nel mondo esterno ad essa. Gesù dice, per esempio, alla Valtorta, che lì dove il cuore è, lì convergono l’intelletto, la parola, lo sguardo, l’azione […]
Si fonda a Torino una nuova realtà cattolica, il Ciprel (Centro Internazionale di Preghiera Laicale). La spiritualità e le attività di questo centro sono ispirate alla testimonianza e all’insegnamento di Maria Valtorta, tramandati nei suoi scritti e manifestati nella sua stessa esistenza personale. In questo libretto costitutivo vengono presentati i principi e i fondamenti operativi teologico-spirituali.
[1] Se ne parla in modo esteso nell’opera di F.G. Silletta, La fede languente, Edizioni La Casa di Miriam, Torino 2023, passim.
[2] Il sottotitolo è: “Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta”: si evidenzia, quindi, il carattere realmente teologico dell’opera della Valtorta.
[3] Il concetto di “parte”, come quello di “partecipazione”, sono fondamentali nell’opera valtortiana.
[4] Ve ne sono anche di individuali, non tuttavia in Chiesa, ma negli ambienti della Casa di Miriam.
[5] Il Ciprel è infatti un’organizzazione laicale.
[6] E ogni affiliato di altre città in un suo ambiente idoneo.
[7] Queste letture non sono sempre necessariamente tratte dagli scritti di Maria Valtorta, ma anche da altri santi, mistici o teologi. Ciò nulla toglie al fondamento valtortiano della nostra attività spirituale.
Disponibile il testo con spedizione in Italia e all’estero in 24h – “La fede languente. Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta” – di Francesco Gastone Silletta – 1ª edizione © Copyright Edizioni La Casa di Miriam:
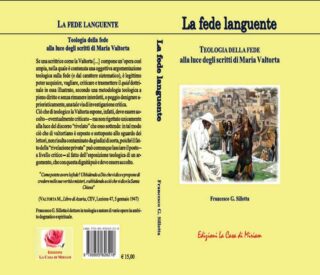
In questo suo essere entitativamente possibile, la fede cristiana è un mistero. La possibilità che l’uomo possa allontanarsi di sua volontà dalla salvezza che Dio, in Cristo, gratuitamente gli dona mediante la fede, non ha “naturali” spiegazioni. In un dialogo molto pregnante, che si rinviene nell’opera di Maria Valtorta, fra Gesù e l’Apostolo Matteo, viene enfatizzato questo mistero del rifiuto della fede: (Matteo vede il Maestro inquieto, e gli si avvicina nella notte, ndr., e Gesù gli dice): “Matteo, tu non sei uno semplice come Pietro e Giovanni. Astuto sei, e sei istruito. Sii anche schietto. Saresti tu felice di queste conquiste? (Gesù si riferisce alla “finta” conversione di Eli il fariseo, e alla “mezza” conversione di suo cugino Simone di Nazareth. Matteo si stupisce che Gesù non ne sia contento. Gesù gli dice ancora, ndr.): “[…] Matteo, tu eri realmente convertito. […] Venivi a me senza tutto un lavoro di pensiero, venivi per volontà di spirito. Non così Eli, e neppure Simone […]. Non sono queste conversioni, sotto pungolo di considerazioni umane, che mi fanno felice” .
L’esempio posto qui sopra, ovviamente, corrisponde al tempo stesso della predicazione pubblica di Gesù. Si può tuttavia estendere, quello che di teologico esso significa, come valido per ogni tempo (perché, ancora una volta lo evidenziamo, la teologia della fede trascende la storia). La Valtorta mette in luce il limite teologico di una fede soltanto umana, la quale impedisce una integrale adesione a Cristo della persona. La dimensione di “possibilità”, che abbiamo detto essere peculiare della fede nella misura in cui, ad essa, si può opporre un cosciente diniego, è intrinseca a determinate decisioni umane che conducono lontano dal Cristo, o quantomeno non in comunione con lui, nonostante l’evidenza di determinati segni, siano essi di natura taumaturgica (Eli il fariseo, ad esempio, aveva ottenuto da Gesù la guarigione miracolosa del nipote) o addirittura di parentela, come nel caso del cugino Simone, fratello di Giuda, Giacomo e Giuseppe .
Questo aspetto dell’umano, inteso come istanza da superare, trascendendo se stessi, nella fede cristiana, è di capillare importanza nella teologia della fede valtortiana, e necessita perciò di una specifica argomentazione. […]
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Piazza del Monastero, 3 – Torino
Tel. 340589274
Sconti Natale 2023 –
Disponibile con sconto del 30% e consegna in 24h:
“La lettera di San Giacomo – Linee di ermeneutica della comunicazione” ***
[…] Il suo stile scritturistico, la dolcezza espositiva sono uniti a momenti di improvviso fomite locutorio, talvolta formalizzato in espressioni apparentemente fuori dai “cardini” della mite esposizione esortativa, come “gente infedele!” (4,4) o, in riferimento ai ricchi: “Piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano!” (5,1). In questo senso, il linguaggio, la tonalità comunicativa, la retorica e lo stile scritturistico sembrano potere rivelare dell’autore alcuni elementi ai quali la pura ricerca storico-critica, né qualunque altra ricerca extra-testuale possono in ultima pervenire, poiché sono le parole stesse a dire l’ultima parola sull’autore che le pronuncia. L’identità dell’autore, seppure soltanto in forma ideale (autore implicito), può così essere tratteggiata in larga parte a partire dalla sua stessa esposizione, dalla maniera in cui comunica il proprio messaggio, dalla sua tecnica letteraria, retorica e da molti altri aspetti testuali che in fondo costituiscono la “forma” stessa della sua lettera. Se questa identità dell’autore, da un punto di vista stori-co, può risultare come “nient’altro che un’impalcatura della nostra mente, fatta con l’aiuto di elementi della storia narrata” , è pur vero che questa stessa identità può condurre il lettore ad una comprensione maggiormente “pura”, nel senso di oggettiva, del fine stesso a cui la lettera mira in maniera “sintetica”, cioè tramite il ricorso a condensati enunciati estratti dall’esperienza comune e proposti attraverso un “immaginifico” corredo di allegorie, similitudini e metafore che vanno a cogliere il segno non in modo divulgativo, ma “secco”, diretto al cuore del lettore stesso.
Su di sé come sui propri lettori (reali) l’autore elabora una sola informazione: di se stesso dice in apertura il proprio nome, Giacomo, e la qualifica, in fondo piuttosto evasiva . Dei destinatari, allo stesso modo, l’autore non usa particolari estensioni descrittive, ma si limita all’ancora vaga, a suo modo, espressione delle “dodici tribù disperse nel mondo” (1,1).
Unità e sintesi contraddistinguono da principio l’intento e l’esposizione dell’autore, il quale non divaga in esplicitazioni nominali, identificatrici, personalistiche rispetto a qualcuno in particolare, ma ruota in maniera unitaria attorno al suo nucleo contenutistico, elaborato dapprima a livello ideale e quindi e quindi esteriorizzato secondo una calibrata andatura scritturistica. La “forma” della lettera ci pare allora il fattore chiave nell’ermeneutica della lettera stessa, il polo dominante attraverso il quale la comunicazione di Giacomo può sviscerare se stessa nel proprio fine, ma anche nel proprio incipit linguistico e teologico.
In questa prospettiva intendiamo analizzare in questo lavoro proprio l’aspetto “formale” della lettera di Giacomo nel suo essere un testo comunicato ad una comunità di lettori da lui stesso previamente identificati (1,1) e pur tuttavia acquisito dalla storia stessa come testo fruibile, nella sua significazione, da una ben più ampia assemblea di destinatari – noi tutti figli della Chiesa – i quali evidentemente sono chiamati in una maniera distinta, rispetto al primitivo destinatario, a cogliere il medesimo contenuto e lo stesso vincolo di dipendenza da colui che l’ha una volta per sempre elaborato nello scritto. […]
*** di Francesco Gastone Silletta
1ª edizione Tel. 3405892741
© Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
www.lacasadimiriam.altervista.org
Disponibili cartoline plastificate con preghierine per necessità varie:

Il mio intervento al Convegno Nazionale su Maria Valtorta dello scorso 14 ottobre 2023. F.G. Silletta
Iniziamo la Novena al Servo di Dio Matteo d’Agnone, teologo ed esorcista – Ricorrenza il 31 ottobre ***
*** Testi di F.G. Silletta – Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
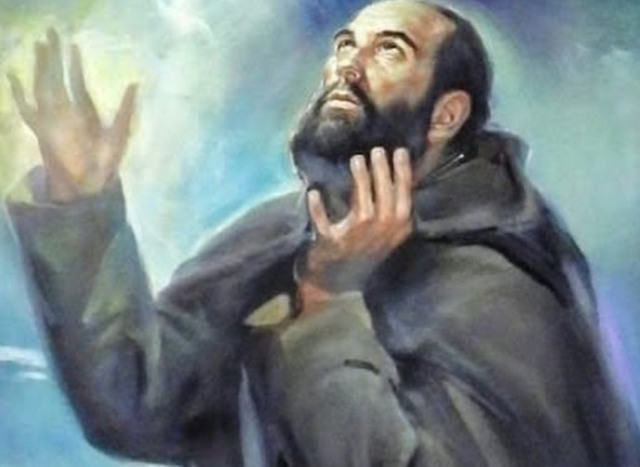
1° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che con umiltà hai testimoniato l’amore di Cristo,
nello speciale ministero della liberazione,
noi rivolgiamo la nostra preghiera,
nella speranza cristiana, che non delude mai,
della tua intercessione per noi.
Con la tua carità e la forza della tua fede,
ti sei manifestato pietra d’inciampo (cf. Ger 6,21)
per molti demòni, che legavano i figli di Dio
nel peccato e nella malattia.
Tu hai preso su di te le loro sofferenze,
ti sei caricato dei loro dolori
e tutto hai consegnato alla misericordia di Cristo,
che per tuo mezzo ha moltiplicato il suo perdono (cf. Sir 18,11).
La tua umiltà ti ha reso giusto agli occhi di Dio,
poiché chi confida nel Signore è al sicuro (cf. Pr 29,25)
e non teme nulla del domani
fidandosi dell’amore provvidente del Signore.
In te, dunque, noi confidiamo,
come fratello che prima di noi ha vinto il Maligno
e che ora dal Cielo ci difende dai suoi assalti,
affinché anche noi otteniamo in eredità
il regno di Dio e la sua giustizia (cf. Mt 6,33).
Aiutaci, Matteo,
a crescere nella fede in Gesù Cristo,
che non abbandona mai nessuno di quanti lo invocano;
ascolta la nostra preghiera
e difendici dallo scoraggiamento.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
2° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che hai dedicato molto tempo allo studio della Scrittura
e ti sei prodigato nella difesa della verità
che la fede cattolica insegna e trasmette,
noi domandiamo per noi lo stesso amore per la divina parola,
perché “senza la rivelazione il popolo diventa sfrenato” (Pr 29,18)
e noi non vogliamo che ciò avvenga per noi.
Per questo preghiamo te,
così zelante per quanto Dio ha comunicato di se stesso,
di non cercare altrove le risposte ai dubbi e alle domande
che l’esistenza ci pone,
ma di saperle individuare,
di riuscire ad accoglierle,
di accettarle ed amarle così come sono
secondo la divina rivelazione,
senza opporci alla legge di Dio,
che ha eseguito progetti meravigliosi (cf. Is 25,1)
e che ancora ne compirà nel tempo a venire.
Illuminaci, dunque, santo ed umile teologo,
anzitutto nel fondamento stesso della nostra conoscenza,
ossia il dono della divina parola
e dell’amore per essa,
affinché nelle sue meraviglie possiamo contemplare
l’amore e la santità di Dio
e iniziare un’esistenza nuova.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
3° giorno
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che sei stato ricordato nei secoli
come un umilissimo servo del Signore,
distante dalle umane osannazioni
ed insensibile alle mondane seduzioni,
noi chiediamo che il nostro sguardo
sia costantemente proteso alle realtà celesti
e non ci siano interferenze di sorta nel nostro amore per Dio,
che salva come un gregge il suo popolo (cf. Zac 9,16)
e ricompensa in modo smisurato
il più piccolo atto d’amore.
Nella tua esistenza umana
ci hai testimoniato la fortezza nella fede,
che doma i leoni dello spirito
e placa le tempeste del cuore.
Aiutaci, dunque, santo fratello,
a stemperare la nostra anima
dai fomiti del peccato
e dall’ansia del domani,
lasciando che come un vento leggero
lo Spirito Santo governi il nostro cuore.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
4° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che hai riconosciuto e venerato i meriti di Maria SS.
quale privilegiato itinerario verso i beni del Cielo
e rifugio sulla terra dalla malizia del peccato,
noi supplichiamo l’ottenimento della fede,
della purezza e dell’obbedienza,
che hanno caratterizzato l’esperienza umana
della nostra comune Madre,
che tu ora contempli nei Cieli
e che noi nella preghiera invochiamo.
Tu con sapienza umilissima
hai divulgato la devozione autentica alla Madonna
e con coraggio e risoluta fede
hai manifestato con le opere
la dottrina che insegnavi.
Aiuta dal Cielo anche noi,
così assetati di verità,
ad ottenere sapienza e virtù,
nella totale compiacenza di Maria,
affinché per la tua intercessione
non manchi mai per noi
la sua materna protezione.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
5° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che ti sei reso amabile con le tue parole (Cf. Sir 20,13)
senza per questo cadere mai nella vanità
e nella compiacenza di te stesso,
lasciando che fosse Dio ad essere glorificato dalle tue parole
e tu unicamente in questo trovassi la tua gioia,
insegna anche a noi a lavorare per il Signore
senza legame alcuno con l’umana compiacenza,
affinché non siamo schiavi di noi stessi
e sensibili ai giudizi del mondo.
Orienta la nostra vita al volere divino,
nel quale tutto è contemplato dei nostri agiti,
in modo che imitando te
Dio si compiaccia di noi
e nella sua compiacenza
troviamo la nostra pace.
Siamo peccatori, fratello Matteo,
che cercano in te illuminazione e speranza.
Aiutaci, per questo,
a camminare sulle vie di Dio
lungo questo breve esilio sulla terra.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
6° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che con instancabile impegno, nel tuo ministero,
hai arrischiato la tua vita
pur di avvicinarti a Dio (Cf. Ger 30,21b)
e hai benedetto tante anime che cercavano benedizione
venute alla luce della fede grazie alla tua predicazione,
alla tua testimonianza e al tuo insegnamento,
noi chiediamo aiuto e protezione,
affinché la nostra fede non vacilli,
la nostra speranza non sfiorisca
e la nostra carità non si fermi.
Rendi feconde le nostre intenzioni
con la forza della tua intercessione,
perché nella gloria dei santi tu possa avere uno sguardo su di noi,
ancora viandanti e pellegrini sulla terra
e dare vigore al nostro cammino spirituale
invocando su di noi lo Spirito Santo.
Desta dunque, santo Matteo, la nostra coscienza
ad ogni voce del divino Consolatore
e procuraci un rinnovato impegno
al servizio del Vangelo.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
7° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che hai consumato la tua vita nella predicazione di Cristo,
liberando tanti fratelli dall’oscurità del male
e dai lacci del peccato,
noi domandiamo liberazione dalle insidie diaboliche
e purificazione da ogni contaminazione con la colpa.
Tu hai insegnato il perdono come fondamento stesso del Vangelo
affinché come luce che irrompe nella vita
esso permettesse di credere contro ogni evidenza di dolore
e di non temere mai nulla, continuando solo ad avere fede (Cf. Mc 5,36).
Dal perdono ricevuto, tu hai insegnato
il perdono donato, la capacità di trasmettere a chiunque
ciò che gratuitamente e immeritatamente si è ricevuto:
vedendo te, quindi, si poteva vedere l’amore
nella sua oggettiva comunicazione ministeriale.
Donaci la capacità di divenire anche noi,
come tu lo sei stato, espressione viva dell’amore di Cristo,
che non coltiva risentimento,
non macina rancore e non chiede conto delle offese;
rendici capaci di aspirare alla carità perfetta,
senza voltarci indietro al nostro passato
e mediante tale aspirazione
divenire incarnata ed oggettiva manifestazione
della Carità di Dio, che muove i suoi figli alla sua imitazione
e li fortifica nella loro intenzione.
Aiutaci, dunque, fratello Matteo,
affinché nessuna debolezza sia impedimento verso il Cielo,
ma tutto concorra ad esso,
anche le amarezze e le sofferenze di questa vita,
come doni da offrire al nostro comune Salvatore.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
8° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
che con ossequio ed umiltà hai meditato la legge di Cristo,
in modo che essa divenisse connaturale al tuo modo di agire,
di ascoltare ed aiutare il prossimo,
avendo nel tuo cuore l’immagine stessa, viva e lucente
del Cristo glorificato,
noi chiediamo luce e temperanza,
affinché per la tua preghiera in nostro favore,
non ci facciamo spaventare alla vista dei nemici (Cf. Ger 1,17b)
che vorrebbero silenziare la nostra testimonianza del Vangelo.
Tu hai saputo superare le ostilità
senza mai violare il precetto della carità,
restando umile dinanzi agli applausi
e sereno dinanzi alle offese:
aiutaci dunque nella temperanza dello spirito cristiano,
perché mai si inorgoglisca il nostro cuore,
quando siamo nell’abbondanza,
né si spaventi il nostro spirito,
quando è l’ora della prova.
Benedicici come tuoi figli spirituali,
santo imitatore di Maria santissima,
alla cui devozione hai condotto tanti fratelli
che non trovavano la santa strada del Signore.
Indica anche noi alla santa Madre nostra
quali suoi figli bisognosi di cure e di misericordia,
affinché mai naufraghiamo nello sconforto
e la sua mano materna ci risollevi sempre
dall’inquietudine e dalla sofferenza dei nostri peccati.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
9° giorno:
Antifona:
Non c’è nulla di nascosto che non debba manifestarsi,
né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce (Lc 8,17)
Preghiera:
A te, fratello Matteo,
il cui cuore sempre fremeva di compassione
quando qualcuno bussava alla sua porta
e che sempre era sollecito e solerte
alle richieste di assistenza e di conforto spirituale,
noi domandiamo misericordia e sostegno dinanzi al Santissimo Signore,
consapevoli della nostra debolezza
e di tutta l’eredità dei nostri peccati.
Tu hai insegnato a sperare cristianamente,
senza mai dubitare della commozione di Dio
dinanzi al fremito dell’umano pentimento:
donaci, dunque, di non soccombere al peso dei ricordi dolorosi,
alle fatiche spirituali che impone talvolta la memoria,
ai carichi negativi con i quali il Maligno assedia i nostri pensieri.
Gioia, fede, luce e speranza erano sempre nel cuore della tua predicazione
e il tuo comando sulle potenze diaboliche è stato sempre vittorioso,
poiché fondato sulla potenza di Cristo
e cosparso dell’amore eterno di Dio:
prega allora per noi,
e per tutti quelli che attraverso di noi conosceranno Gesù Cristo,
affinché anche noi possiamo governare ogni avversa infatuazione,
ogni attacco del Nemico
e testimoniare nella grazia e nella santità
l’onnipotenza del Salvatore,
che tu hai servito instancabilmente fino alla morte
e che noi come te vogliamo servire.
Amen
(Gloria al Padre)
Servo di Dio, Matteo d’Agnone, prega per noi
Preghiera conclusiva
Signore Gesù,
noi ti benediciamo e ti ringraziamo
per tutto ciò che hai operato per noi,
assumendo una condizione simile alla nostra
e offrendo la tua vita per la nostra redenzione.
Perché la conoscenza di te e del tuo amore infinito
si diffonda in tutti i cuori
generando conversione e santificazione delle anime,
noi ti offriamo questo percorso di preghiera
nella memoria del tuo servo Matteo d’Agnone,
affinché ti sia gradito il nostro intento
e tu abbia compiacenza per noi.
Tu sei santo, Gesù,
e santo è chi santifica il tuo nome,
chi lo testimonia nella vita
e lo invoca nella preghiera per il bene comune,
come occorso magistralmente con il tuo servo Matteo.
Salga dunque a te,
autore della Vita,
la nostra piccola ma sincera offerta dei suoi meriti,
mediante questo breve itinerario di preghiera
nel quale abbiamo meditato le sue virtù,
evocato il suo santo ministero
ed invocato la sua intercessione.
Per la potenza dello Spirito Santo
donaci la grazia di una continua conversione del cuore.
Amen
*** Testi di F.G. Silletta –
Disponibile – Nuova ristampa del libro “La fede languente. Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta” – Spedizioni ovunque in 24h
– (Per l’indice dell’opera, v. qui un po’ più sotto)
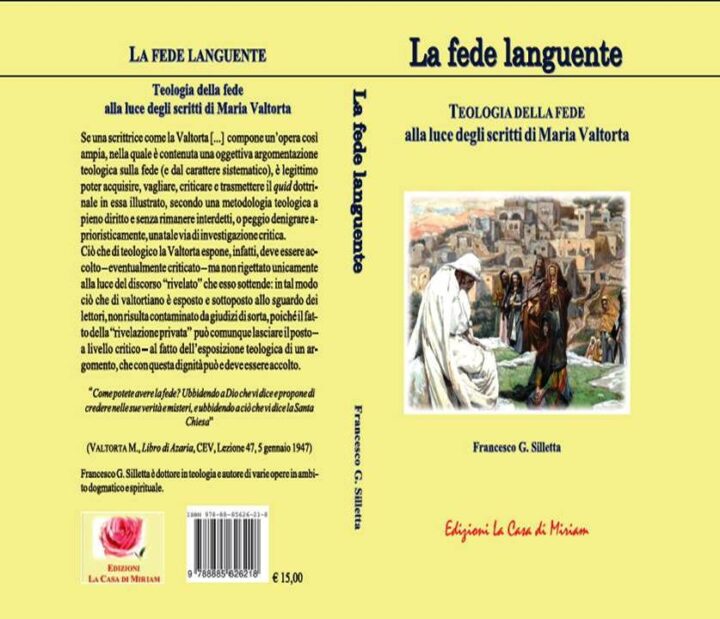
“Papa Francesco scrive che “nella fede, l’‘io’ del credente si espande per essere abitato da un Altro, per vivere in un Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore. Qui si situa l’azione propria dello Spirito Santo. Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione filiale, perché viene reso partecipe del suo Amore, che è lo Spirito. È in questo Amore che si riceve in qualche modo la visione propria di Gesù”.
Credendo in Cristo, il pensiero dell’uomo si dilata, amplia la sua estensione, assume lo stesso pensiero di Cristo (cf. 1Cor 2,16). La fede infonde maternamente all’attività pensante umana una luce non auspicabile, la Luce stessa di Cristo, affinché l’esito di quella stessa attività sia un pensiero nuovo, un pensiero, per questa sua unione a Cristo stesso, “perfetto”. In tal modo, mediante la fede, il pensiero spiritualizza a suo modo l’esistenza soggettiva e la eleva al di sopra dell’io-carnale, dando una caparra già in questa vita dell’unione con Dio che si possederà definitivamente nella vita eterna. Questo percorso del pensiero – che è un percorso di trascendenza mediante la fede in Cristo – orienta tutta l’attività pensante ad un investimento noetico sulle cose del Cielo, con un sereno, rassegnato, distacco dalle cose del mondo.
Dice, in tal senso, la Vergine Maria in un suo discorso alla Valtorta: “È sapersi distaccare dal proprio modo di pensare umano. Il pensare umano di che è composto? Per metà da risentimenti, per un altro quarto da eccessiva sensibilità, e per l’altro quarto da egoismo. Un prossimo sfiora con una corolla o con una piuma? […] L’egoismo allora scatta: ‘Io sono re e non voglio offese di sor¬ta. Io impero e non voglio resistenze al mio volere’. […] Ecco: ‘Si vis perfectu esse va, vende quae habe’, ha detto il Figlio mio. Ed io ti dico: se tu vuoi essere perfetta vieni, metti nella mia mano il tuo modo di pensare, l’attaccamento ad esso e soprattutto i risentimenti. Io li getterò sul rogo della Carità. […] Pensa da figlia di Dio”.
La maternità della fede conduce il pensiero a questo adeguamento alla filiazione divina, al pensare da figli di Dio: avendo il pensiero di Cristo – nella fede in lui – si pensa infatti come veri figli di Dio.
Proprio alla luce di questa possibilità di trascendenza, intrinseca alla fede, Gesù domanda un pensiero perfetto, l’essere perfetti soggettivamente, secondo una misura di riferimento molto alta, quella stessa del Padre suo (cf. Mt 5,48). Dice a riguardo Gesù ad un giovane che incontra in uno dei suoi viaggi e che gli chiede consiglio su questa perfezione, che gli pare impossibile da ottenere: “Figlio mio, e potrei essere venuto a proporre cose impossibili agli uomini? Chi pensi tu che sia stato a metterti in cuore questo desiderio di divenire perfetto? Il tuo stesso cuore? […] Dunque è stato Dio. Ora rifletti: se Dio, che sa le capacità degli uomini, dice loro: ‘Venite a me. Siate perfetti’, segno è che sa che l’uomo, volendolo, lo può divenire. È voce antica. È risuonata la prima volta ad Abramo come una rivelazione, un comando, un invito: io sono l’Iddio onnipotente. Cammina alla mia presenza”.
Francesco Gastone Silletta – “La fede languente. Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta” – Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam – Tel. 3405892741 – Piazza del Monastero 3 Torino – info@edizionilacasadimiriam.it
www.lacasadimiriam.altervista.org
Novità – Dal 29 maggio 2023 :
Leone XIII. La teologia, il pensiero sociale e l’esorcismo
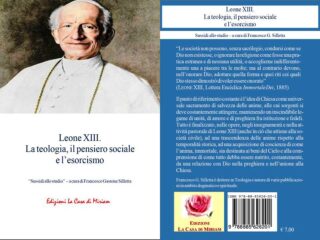 Il punto di riferimento costante è l’idea di Chiesa come universale sacramento di salvezza delle anime, alle cui sorgenti si deve costantemente attingere, mantenendo un inscindibile legame di unità, di amore e di preghiera fra istituzione e fedeli.
Il punto di riferimento costante è l’idea di Chiesa come universale sacramento di salvezza delle anime, alle cui sorgenti si deve costantemente attingere, mantenendo un inscindibile legame di unità, di amore e di preghiera fra istituzione e fedeli.
© 2023 Edizioni La Casa di Miriam – di Francesco G. Silletta – ISBN 9788885626201
Novità – Cartoline colorate con preghiere
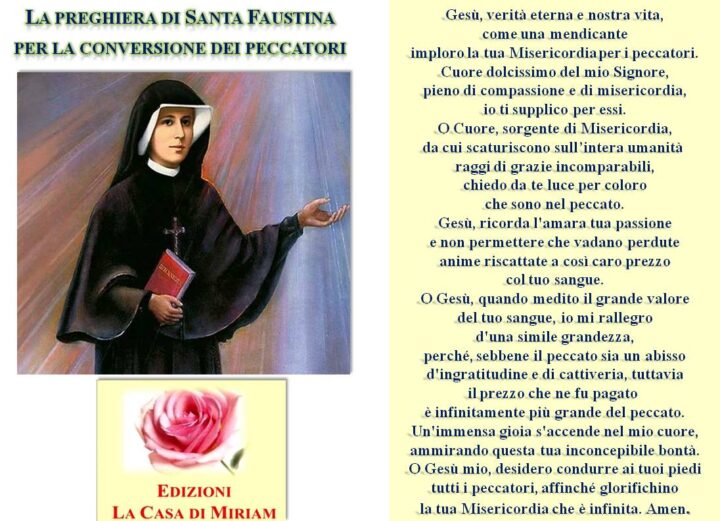
Dal 27 febbraio 2023
“La fede languente. Teologia della fede alla luce degli scritti di Maria Valtorta”

Novità editoriale – Un estratto dall’interno:
“[…] La conoscenza da se stessa è tuttavia insufficiente – anche se agostinianamente ‘illuminata’ dalla grazia – a determinare la fede nell’integralità della sua costituzione. Il concorso di una mozione volitiva è fondamentale in questo senso, in una prospettiva di integerrima adesione alla verità che si è conosciuta. In un suo discorso, il Papa Pio XII – dopo avere evidenziato che talvolta anche alcune menti intellettualmente illuminate, dinanzi alle oscillazioni della loro fede non sono capaci di dire: ‘Credo, Signore, aiutami nella mia incredulità!’ (Mt 17,14; Mc 9,24) – esorta le anime dicendo: ‘Date dunque alla fede in Dio quell’adesione filiale, la quale altro non è, per dirlo più chiaramente, se non l’assenso dell’intelletto alle verità rivelate da Dio, assenso imperato sotto l’influsso della grazia dalla volontà umana, perché non si può credere senza il voler credere, essendo la fede un libero assenso della nostra mente, che prestiamo a Dio a causa della sua autorità infallibile’
Questo concetto intrinseco alle parole di Pio XII, sulla necessità di una confluenza della pura conoscenza di Dio nell’adesione totale alla sua grazia – perché si possa parlare di ‘fede’ in senso pieno – è costante nell’opera della Valtorta. Riprendendo l’esempio, posto in precedenza, di quei due genitori con la figlia in difficoltà, dinanzi a ciò che Gesù in prima istanza dice loro – e che abbiamo riportato, sulla necessità di non perdere la fede – il marito della donna, anche se con un umile rincrescimento, a suo modo istantaneamente dubita, dicendo che al di là della fede richiestagli da Gesù, ormai il libello di divorzio doveva essere già stato realizzato e dunque, il matrimonio di sua figlia, annullato. Gesù mette in luce come nell’anima umana non debba sussistere un’ipotesi ‘al di là’ della fede, capace in qualche modo di indebolirla nel suo slancio verso Dio. Dice ancora Gesù, quindi, a quell’uomo: ‘Abbi fede, ti dico! […] La vostra preghiera insistente e fiduciosa, fatta a buon fine, non è forse un volere santo, opposto al mal volere dell’uomo? […] E Dio, poiché chiedete cosa buona […] non vi avrà forse già aiutato?’ .
Dopo queste parole di Gesù, i due sposi abbandonano ogni dubbio e confidano nel buon esito di quanto sperano. Un particolare interessante, qui, è che Gesù non dica affatto ai due sposi chi egli sia: la fede che egli domanda la domanda per Dio, non per se stesso ai loro occhi. E questo con una ragione esplicitata poi ai suoi discepoli: ‘(Se avessero saputo chi sono, ndr.), avrebbero pregato con pace, ma con meno valore. Con meno merito. Così la loro fede è perfetta e sarà premiata’.
La verità, che con l’intelletto è conosciuta e che lo slancio fiduciale – di cui si è parlato in precedenza – muove a un radicamento di completezza formale, implica l’esistenza di una tensione, nella fede, all’adesione a se stessa, non nella singolarità di una facoltà umana, o nella temporalità di un momento, ma nell’integralità della persona e per tutto il tempo della vita. La fede ha questa intrinseca necessità strutturale, solo alla luce della quale può ricevere una trasfigurazione nelle opere e una eventuale misura alla luce di esse. […]”
L’indice dell’opera
(Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam):
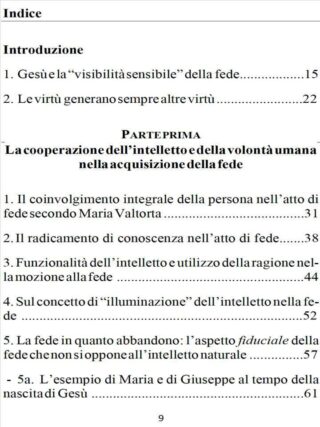
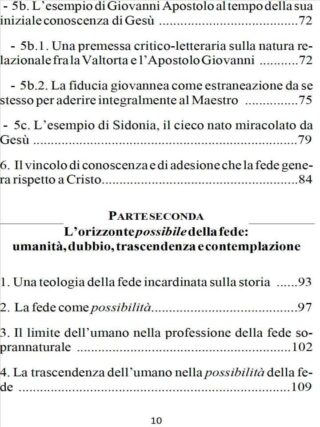
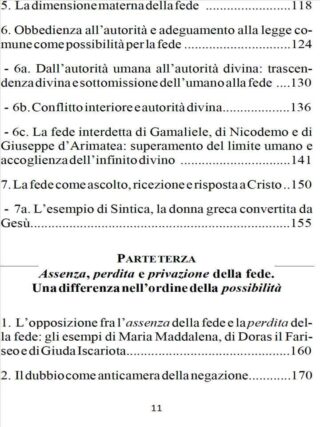
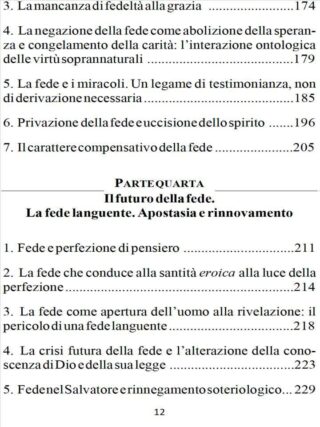
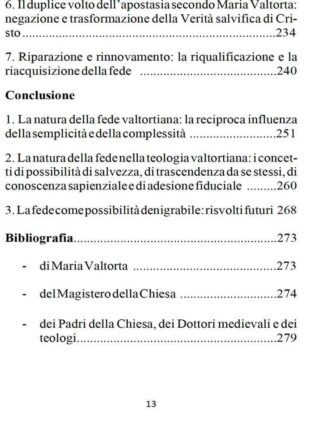
***Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Tel. 3405892741
Piazza del Monastero 3 – Torino
www.lacasadimiriam.altervista.org
Preghiera di liberazione alla carne umana del Salvatore ***:
Bambino Santo Gesù,
per la tua carne innocente,
che proprio a motivo della sua indicibile purezza
è stata destinata ad assumere ogni impurità degli uomini,
essendo essa l’unico sacramento possibile
di tanta dissomiglianza dal Creatore,
eterno e santo, puro ed infinito,
con la quale il peccato ci ha trasformati e resi immondi:
abbi compassione di noi.
La tua incarnazione nella storia, presagita dai profeti,
annunziata dagli angeli, cantata dai pastori,
glorificata dai Magi
e soprattutto assistita nella fede e nell’offerta santa di se stessi
da parte di Maria e Giuseppe,
nostri umani genitori spirituali,
ci ottenga il permanente dominio sulla nostra carne,
in avanti e indietro nel tempo,
nella santità e nella liberazione
da tutto ciò che contraddice l’Incarnazione del Figlio di Dio.
Siano per questo distrutte, bruciate dinanzi alla tua greppia benedetta,
tutte le potenze oscure, le forze diaboliche che inquinano i sensi,
che maledicono la carne, che la rendono schiava del peccato.
L’innocenza della tua carne umana comandi per noi, o divino Salvatore,
ad ogni pensiero, immaginazione, memoria, attività del corpo e della mente,
di essere liberi da Satana e da tutti i suoi spirituali satelliti,
affinché nulla di ciò che tu hai assunto per la nostra redenzione,
torni ad essere schiavizzato dal serpente ingannatore,
dalla sua malizia e dal suo peccato.
La tua culla di Betlemme sia la fonte del nostro permanente esorcismo
da colui che è inganno e seduzione;
la tua santità carnale di infante divino
sia il fuoco che distrugge ogni diabolica perversione,
come santa anticamera di quella medesima carne
afflitta e crocifissa per la nostra purificazione,
che distrugge in eterno l’abominevole accusatore.
Assumi dunque tutti noi, Gesù, in quella tua santissima carne umana,
con ognuna delle nostre contraddizioni e ogni singolo peccato,
affinché dalla grotta di Betlemme, alla croce sul Golgota,
noi possiamo venire dietro a te,
nostro Dio e Salvatore,
nostro amico e nostro re.
Lascia che possiamo ottenere questa grazia,
affinché anche per noi oggi sia segnata in Cielo una vera natività:
la rinuncia definitiva al peccato,
la separazione eterna dal Maligno
e l’eterna compagnia di te, Gesù Amore vivo,
amore santo, amore senza fine,
che regni nei secoli. Amen
F.G. Silletta – 4 volumi – Liberaci dal male
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Dal 2 febbraio 2023:
“Novena alla Nostra Signora di Lourdes”
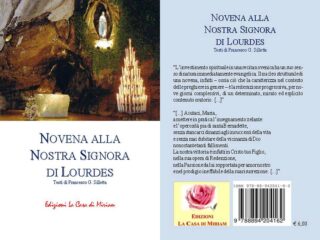
Dal mese di Novembre 2022:
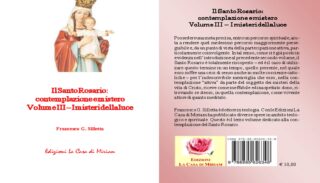
“Il santo rosario: contemplazione e mistero – Vol. 3”
€ 10,00 – di
FORMATO Brossura
EDITORE La Casa di Miriam
EAN 9788885626348
ANNO PUBBLICAZIONE 2022
CATEGORIA Religioni
LINGUA ita
Dal mesei di Novembre 2022 – Novena alla Vergine della rivelazione
di

EAN: 9788885626126 – Dall’interno:
“L’esperienza storica delle apparizioni della Vergine al veggente – divenuto tale per grazia – viene a proporre alla nostra vita cristiana un’occasione di intensiva ed adeguata conformazione al desiderio divino rispetto al nostro modo di relazionarci a lui nella preghiera e nel nostro ordinario inserimento sociale. Trarre un frutto spirituale copioso e consistente è non solo una grande occasione che la grazia dispone per noi, ma insieme un nostro preciso dovere, tanto più alla luce del contenuto della rivelazione della Vergine alle Tre Fontane. Esso, in fondo, si concentra in precisi punti, che possiamo definire come “sostanziali”, nel senso che, al di là di un’esplicita “forma”, estrinseca al contenuto proprio dell’apparizione (ad esempio il modo in cui la Vergine appare, il suo abito, il tipo di reazione del veggente, il contesto, ecc.), rappresentano il nucleo di senso di ciò che la Vergine – tramite l’apparizione – intende farci conoscere o esortarci a compiere”.
Novità Editoriale – Estate 2022:
“Getsemani. Il giardino che appassendo al peccato, fiorisce alla grazia”
di

Pagine 80
Formato Libro 13×18
Costo € 7,00
Isbn o codice id 9788885626263
Acquisti tel. 3405892741 – Consegna a domicilio 24h
Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam Tel. 340589274 Torino
“Ragione creatrice, libertà e linea oscura del male. Estratti testuali dall’insegnamento di Joseph Ratzinger (Benedetto XVI)” –
di
Editore : La Casa di Miriam
Lingua : Italiano – € 7,50
Copertina flessibile : 128 pagine
ISBN-10 : 8885626289
ISBN-13 : 978-8885626287
Subito Disponibile: Tel. 3405892741
Messali e messalini nella nostra libreria
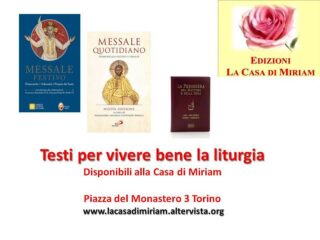
Preghiera per la Natività di Maria SS.
Vergine Santa,
ci raccogliamo oggi nell’intimità filiale rallegrandoci di questo giorno della storia, che vediamo prossimo dinanzi a noi, nel quale la consolazione di Dio si è manifestata all’umanità nella tua generazione carnale, affinché attraverso di te fosse perfetta la rivelazione della sua sollecitudine alla nostra salvezza, creando un grembo puro che desse vita alla Vita, riparo alla Riparazione, conforto al Consolatore .
Ora ti supplichiamo: “Correggi il figlio e ti farà contento e ti procurerà consolazioni” (Pr 29,17). Non considerare la violenza irriconoscente con la quale abbiamo ferito il tuo cuore materno e, come “presi nel tranello” (cfr. Ger 48,44) ci siamo allontanati dalla verità della nostra origine per camuffarci nelle cose del mondo, rifiutando di ascoltarti e voltandoti le spalle (cfr. Zac 7,11).
Il tuo cuore è infatti sede del perdono, fonte della rigenerazione del corpo e dello spirito. Per questo, ringraziando la bontà del Padre, che nel suo Figlio, per la potenza dello Spirito Santo ha pensato a te quale immacolata e santa cattedra d’amore, e ti ha donata alla creazione, creatura tu stessa, quale vincolo materno tra il divino e l’umano, ti supplichiamo di assisterci in ogni momento della nostra vita e di permettere che questa evocazione spirituale della tua nascita valga a noi come mozione della tua misericordia, madre dolcissima che tutto dimentica del male ricevuto e tutto ricorda del bene offerto.
Amen.
(Ave Maria – Credo)
*** Testi di F. G. Silletta – Edizioni Cattoliche e Cenacolo La Casa di Miriam 24h – Piazza del Monastero, 3 – Torino – Tel. 3405892741
NOVENA ALL’ASSUNTA DAL 6 AL 15 AGOSTO 2022 – Il volume:
Editore : La Casa Di MiriamCollana: Spiritualità
Formato: Brossura
Pubblicato: 30/09/2021
Pagine40
Lingua: Italiano
Isbn o codice id9788885626171
Tel. 3405892741
Disponibile: “Senza stancarvi mai”
(Preghiere semplici della devozione cattolica)
Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam Tel. 340589274 Torino
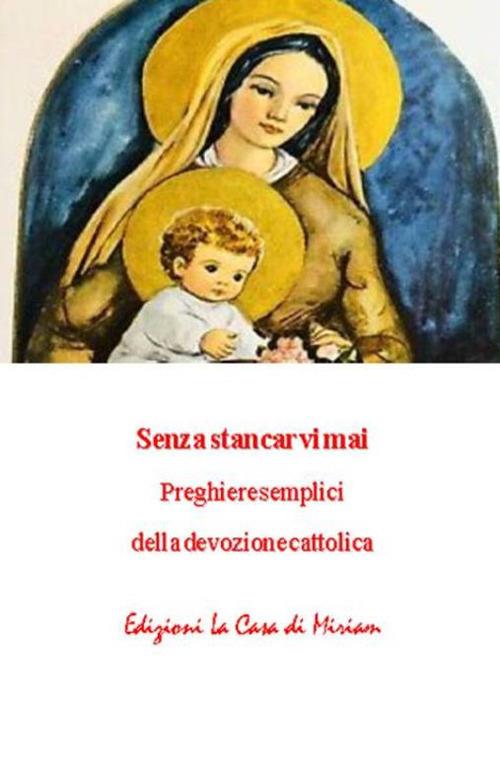 di Francesco Gastone Silletta (Autore) – La Casa di Miriam, 2020
di Francesco Gastone Silletta (Autore) – La Casa di Miriam, 2020
Il 1° dei 4 volumi del testo: “Il santo rosario: contemplazione e mistero” – Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam Tel. 340589274 Torino
 –
–
EditoreLa Casa Di Miriam
Formato: Brossura
Pubblicato: 27/06/2019
Pagine: 63
LinguaItaliano
Isbn o codice id9788885626324
“[…] la recita del Santo Rosario si deve intendere principalmente come una viva attività di contemplazione, non come un atto di ragione o di analisi intellettuale dei misteri della storia di Gesù. La via della contemplazione, infatti, supera quella della ragione per due motivi in seno alla recita del Santo Rosario […] In un primo senso, la contemplazione, illuminata dallo Spirito, penetra oltre il perimetro di mistero relativo alla natura della gloria di Gesù che la ragione di per se stessa non è in grado di superare […] In un secondo senso, poi, la contemplazione garantisce un mantenimento sul piano reale dell’essere da parte del soggetto, proprio per l’umiltà strutturale, sopra descritta, del suo approccio alla verità.
Preghiera di Pentecoste –
Testi, immagini e dispense delle Edizioni La Casa di Miriam
Vieni Spirito Santo, Dio effuso da Dio, Persona eterna che dona la vita, eterno Amore che purifica e consola ogni umano cuore. Vieni su di noi, posati sulla nostra esistenza, dolcissimo ospite per la nostra sofferenza, illuminatore sapiente del nostro intelletto, donaci potenza e pace, luce e gioia, affinché tu possa dimorare in noi, e mai separarti da noi. Vieni Spirito di Pentecoste,ti attendiamo esultanti con gioia, perché il Cristo ci ha promesso Te, ed è salito al Padre per inviarci Te, divino Consolatore, Spirito di Verità. Vieni dunque, vieni ancora, vieni copiosamente, e fa’ di noi il tuo tempio, governa la nostra mente, purifica i nostri pensieri e riempici d’amore. Amen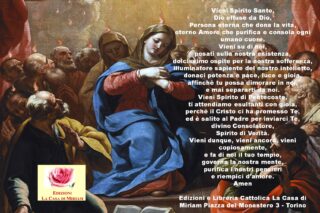
© Edizioni Cattoliche
La Casa di Miriam
Piazza del Monastero 3 – 10146 – Torino
Testo Per la novena di Pentecoste –
© Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Novità – Cartoline con preghiere –
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
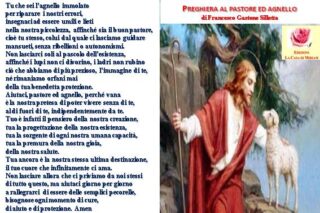
Editore : La Casa di Miriam
Formato cm 10x15 -
Quantità minima ordini - 30 pz.
€ - 0,50 cad.
Subito Disponibile:
“Corso di mariologia dell’intuizione. Dal dogma all’esistenza.
Volume 1: La maternità intuibile”
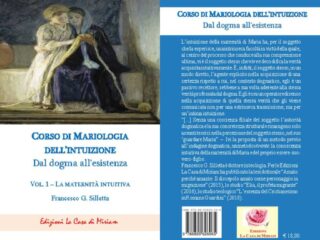 di Francesco G. Silletta pubblicato da La Casa di Miriam
di Francesco G. Silletta pubblicato da La Casa di Miriam
Dal testo (conclusione): ***
L’autocoscienza filiale del soggetto intuitore alla luce del superamento delle opposizioni polari generatesi dalla consegna materno-filiale sotto la croce
Punto primo:
Ampia disponibilità testi di sant’Agostino
alla Casa di Miriam






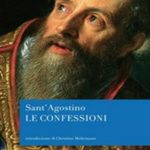
Disponibili quadretti di preghiere personalizzati, con testi della devozione cattolica –
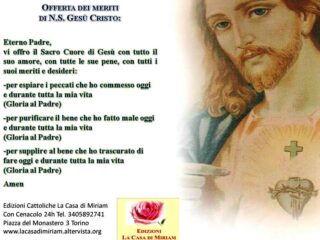
Crocifissi di legno alla Casa di Miriam

NUOVE STATUE DISPONIBILI SUBITO:





Statue sacre, scapolari e oggettistica sacra alla Casa di Miriam

![]()
Collana “TEOLOGIA” Novità:
La lettera di San Giacomo. Linee di ermeneutica della comunicazione
di Francesco G.Silletta pubblicato da La Casa di Miriam
160 pagine – € 18,00 –
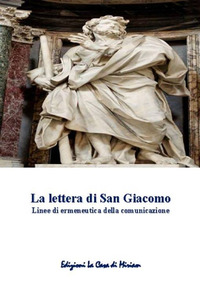 Dall’interno:
Dall’interno:
(Francesco G. Silletta è dottore in Teologia Dogmatica. Ha pubblicato diverse opere in ambito teologico e spirituale).
ICONE E IMMAGINI SACRE DISPONIBILI IN SEDE
IL NUOVO LIBRO DI PADRE AGUSTINUS KRAENG RITAN (cp)
Il libro di un sacerdote della Congregazione Passionista, Padre Agustinus Kraeng Ritan (cp): “Racconto di un passionista missionario in Indonesia” € 10,00 – 76 pagine –
Copyright Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Novità libro di Lino Morato:
“Medjugorje: verso il mondo nuovo di Dio”
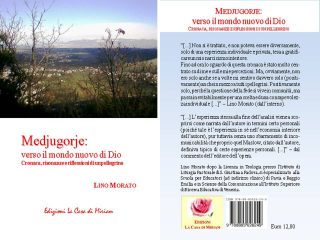
PAPA FRANCESCO ISTITUISCE IL MINISTERO DEL CATECHISTA –
 Lettera Apostolica in forma di Motu proprio: “Antiquum ministerium” –
Lettera Apostolica in forma di Motu proprio: “Antiquum ministerium” –
«Liberaci dal male». Preghiere di liberazione. Testi inediti. Volume 2
di Francesco G. Silletta
pubblicato da La Casa di Miriam
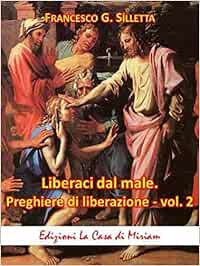
“Vergine Maria, per adempiere come hai fatto integralmente il disegno divino su di te e, attraverso di te, sul mondo intero, hai dovuto sacrificare te stessa in molte delle tue umane possibilità, aspirazioni e progetti, rinunciando a tante cose che riguardano la tua persona, il tuo essere sociale, la tua vita privata, la tua stessa creaturalità umana. Rinunciare per offrire, perdere per trovare, fare a meno per dare: tutto ciò che ti è stato sottratto, nelle tue possibilità, è stato a sua volta offerto, donato e sacrificato perché la volontà divina fosse adempiuta nel tuo consenso e la nostra salvezza potesse permearsi della tua disponibilità al suo compimento. Per questo anche noi ti domandiamo un similare investimento: saper perdere qualcosa di noi stessi, per poterlo dare a Gesù, saper rinunciare alla nostra autosufficienza o alle nostre ambizioni personali, per porle nell’arbitrio divino, affievolire il nostro orgoglio ed abbattere il nostro amor proprio, per essere totalmente figli di Dio in Cristo. Domandiamo a te il coraggio per riuscire in questo proposito, affinché non rimanga unicamente tale, ma si adempia come si è adempiuto il tuo ineffabile scambio con la volontà divina: te stessa, al posto del compiersi di quella, la tua libertà offerta perché Dio potesse liberamente agire per tuo mezzo. In questo dono d’amore possa risultare viva, partecipe, efficace e preziosa, pur nella sua misera piccolezza, anche la nostra decisione: essere per Cristo, sotto la tua tutela materna. Amen
(Francesco G. Silletta - 4 volumi: "Liberaci dal male" -
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
Tanti nuovi prodotti alla Casa di Miriam:
Classici dello Spirito
sempre disponibili alla Casa di Miriam:


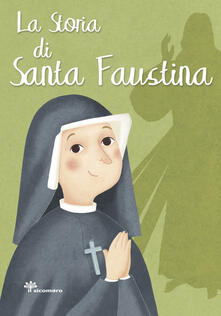
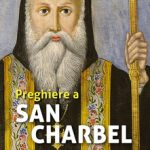
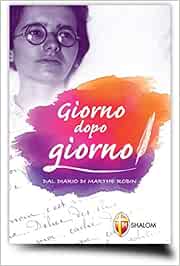


ecc.
STATUE E OGGETTISTICA SACRA


Libri cattolici di vario genere:
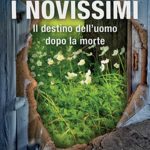
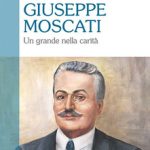
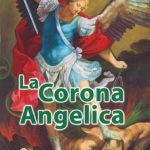
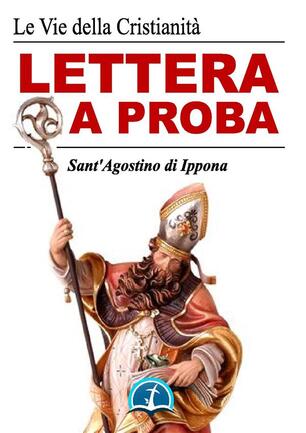
TANTI ROSARI
E CORONCINE DI VARIO GENERE:
 (San Pio)
(San Pio)  (Papa Francesco)
(Papa Francesco)  (S. Teresa)
(S. Teresa)
 S. Rosario classico
S. Rosario classico  S. Rosario cloisonnè
S. Rosario cloisonnè
 Rosario missionario legno (marrone scuro)
Rosario missionario legno (marrone scuro)  Scapolare Carmelo
Scapolare Carmelo
TANTE E DIVERSE PROPOSTE DELLA SACRA SCRITTURA
Il nuovo Messale Romano
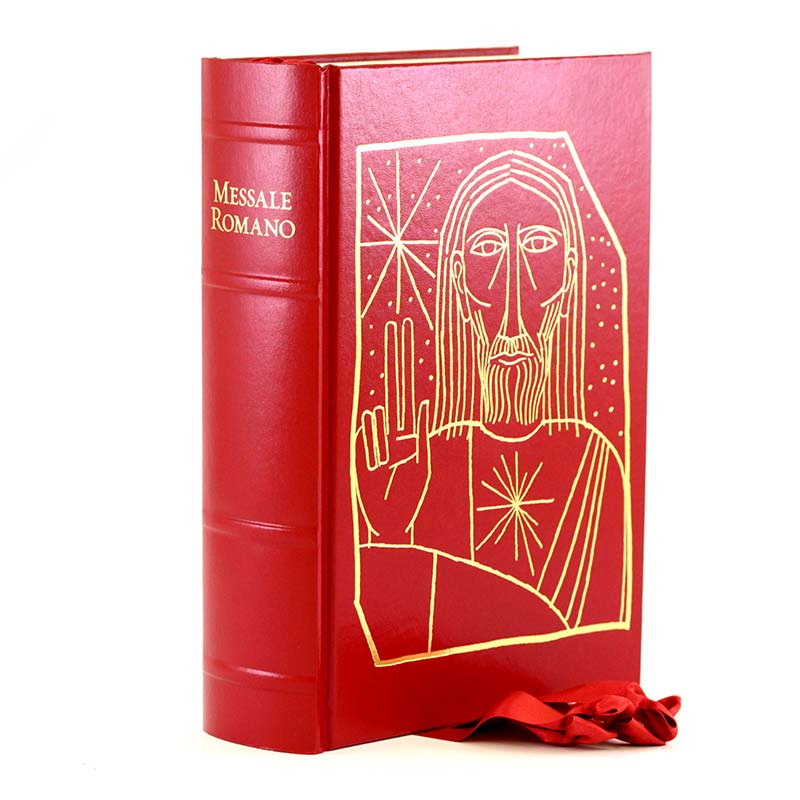 Testo ufficiale con la nuova traduzione italiana – dalla terza edizione tipica latina – che entrerà in vigore obbligatoriamente dalla Pasqua 2021 e che contiene alcune modifiche, per esempio, alla preghiera del “Padre nostro” e del “Gloria”, e ad altre parti che riguardano il sacerdote celebrante.
Testo ufficiale con la nuova traduzione italiana – dalla terza edizione tipica latina – che entrerà in vigore obbligatoriamente dalla Pasqua 2021 e che contiene alcune modifiche, per esempio, alla preghiera del “Padre nostro” e del “Gloria”, e ad altre parti che riguardano il sacerdote celebrante.
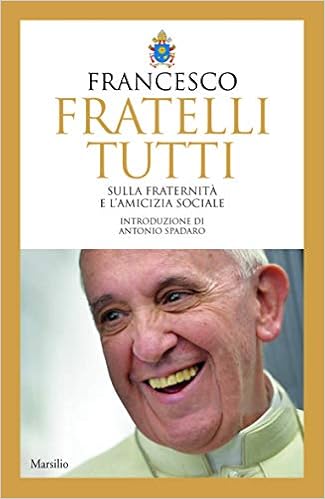
OGGETTISTICA SACRA VARIA:


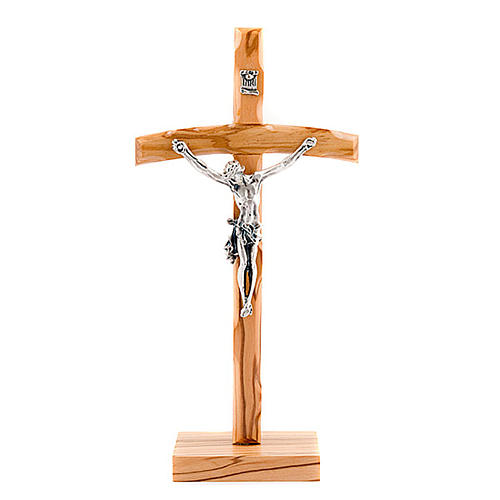

Bibbie e rosari dei bambini
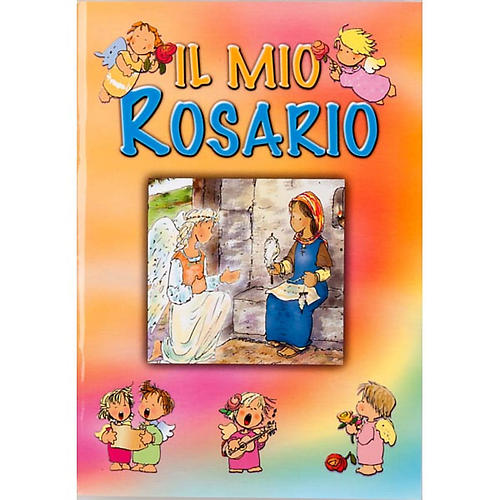
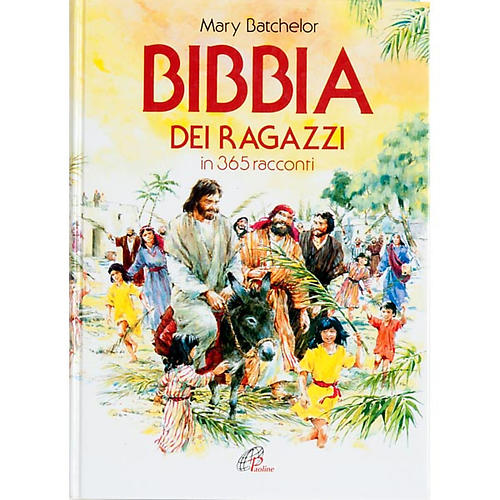

TANTI TESTI DI TEOLOGIA DISPONIBILI IN SEDE
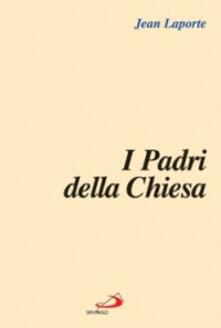
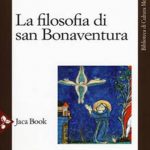
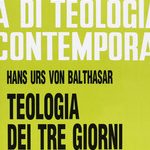
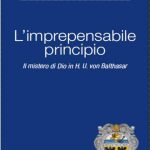
Speciale testi dei Papi – Tutte le encicliche e testi pubblicati dagli ultimi papi
LE PUBBLICAZIONI DELLE NOSTRE EDIZIONI:
NUOVA EDIZIONE DEL 1° DEI 4 VOLUMI DI:
“Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” –
Tante nuove preghiere con ampia introduzione teologica, foto e bibliografia magisteriale sul tema – Nelle librerie cattoliche con distribuzione “La Casa di Miriam” – 196 Pagine – € 12,00 –
Disponibile subito il 2° volume della collana:
“IL SANTO ROSARIO:
CONTEMPLAZIONE E MISTERO”
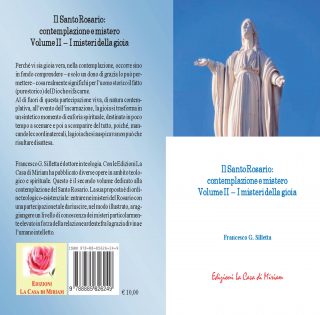
Il secondo volume della collana: “Il Santo Rosario: contemplazione e mistero” (I misteri della gioia). Dopo la pubblicazione del primo volume (I misteri della gloria) ci si concentra ora in questo percorso contemplativo, con riferimenti teologici, alla scoperta dei misteri della gioia e del loro significato spirituale nella partecipazione attiva del credente che medita i misteri del Santo Rosario. Disponibile dal 20 aprile 2020.
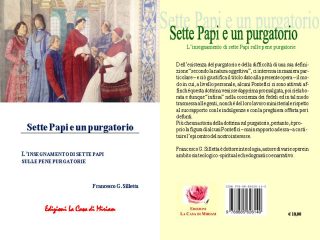 “Sette Papi e un purgatorio”.
“Sette Papi e un purgatorio”.
L’insegnamento di sette papi
sulle pene purgatorie –
Uno studio di cento pagine con l’esperienza dottrinale che alcuni grandi Papi hanno esercitato in riferimento alla verità sull’esistenza del purgatorio e alla conoscenza della sua natura.
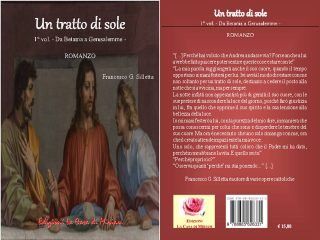 “Un tratto di sole” 1° volume. Da Betania a Gerusalemme (Romanzo)
“Un tratto di sole” 1° volume. Da Betania a Gerusalemme (Romanzo)
Un romanzo ambientato al tempo di Gesù, avente Gesù stesso e i suoi discepoli come protagonisti, secondo la voce narrante del discepolo amato
236 pagine – € 15,00 – 236 pagine – Nelle librerie cattoliche
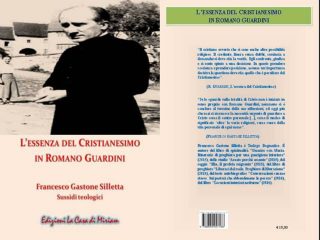 “L’Essenza del Cristianesimo
“L’Essenza del Cristianesimo
in Romano Guardini”
Nuova edizione per studenti –
Un estratto:
“[…] Pensare il Cristianesimo, in R. Guardini, corrisponde all’idea secondo cui “l’uomo deve purificare il suo pensiero per adattarlo al pensiero di Cristo” ]…] L’essenzialmente religioso, con cui Guardini connota l’atto creativo, esprime come all’origine di quest’ultimo vi sia un’istanza divina, un pensiero di Dio, per cui l’uomo, nel proprio dispiegamento esistenziale, non può autonomamente conoscere la propria identità se non mediante uno svelamento divino. […] Ora, per Guardini, se Dio crea l’uomo, significa anche che “Dio ha fiducia che l’uomo saprà comprendere il significato di tale rapporto”; Dio stima l’uomo a tal punto da conferirgli la capacità di riconoscerlo al di là delle tensioni alle quali andrà incontro, conservando in sé un nucleo esistenziale che gli renderà memoria della sua condizione creaturale. Questo grazie alla rivelazione che Dio fa di sé all’uomo, il cui punto fondamentale, a livello esistenziale, è proprio il fatto che “Dio ha un plurale”, cioè “è in se stesso comunità, perciò non ha bisogno di nessun mondo” […].
PER LA PREGHIERA DI LIBERAZIONE DAL MALE – CON GLI INSEGNAMENTI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA SUL TEMA:
3° volume: “Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” – Opera in 4 volumi
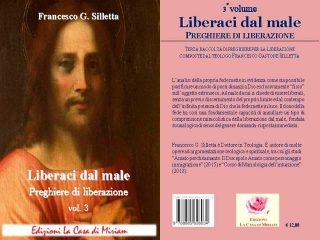
Un estratto dal:
[… ] Spezza in noi, Gesù, per la forza delle sante piaghe delle tue mani, dove i chiodi stabilirono fra il cielo e la terra una salvifica e rinnovata unione, ogni catena di peccato contro il Signore ed ogni legame con le cattive azioni da noi commesse (cfr. Ger 44,22). Per la potenza del tuo sangue, liberaci da Satana, in questo momento, qualunque sia l’altezza, la profondità e l’estensione del nostro peccato. Vadano indietro tutte le sue accuse sui peccati passati, sull’esistenza vissuta e già da noi consegnata alla tua misericordia: retroceda Satana, con i suoi satelliti, e tutte le forme di satanica espressione che vagano nell’aria, nello spazio, sulla terra, tra le persone e persino nei nostri cuori […] – Info Tel. 3405892741
NOVENA A S. MARIA MADDALENA PER LA LIBERAZIONE DALLE OSSESSIONI-
Una novena offerta a questa santa così storicamente vicina a Gesù con la viva speranza che Cristo muova la sua compassione verso gli oppressi e gli ossessi.
PER LO STUDIO TEOLOGICO:
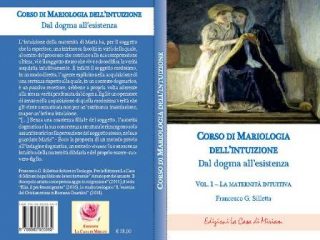
– Libro: “Corso di Mariologia dell’intuizione.
Dal dogma all’esistenza”
di Francesco G. Silletta
Un estratto:
“Amato perché amante. Il Discepolo Amato come personaggio in migrazione. Una rilettura materno-filiale dell’essere amato” – Francesco G. Silletta
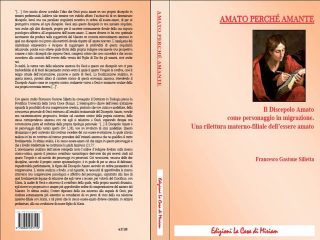
“Elia, il profeta migrante”
Francesco G. Silletta

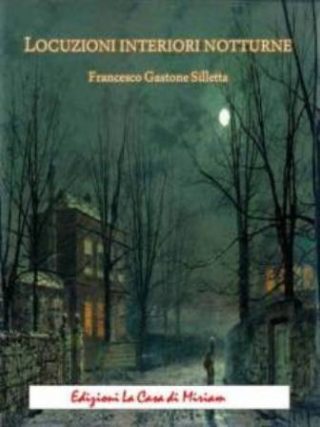
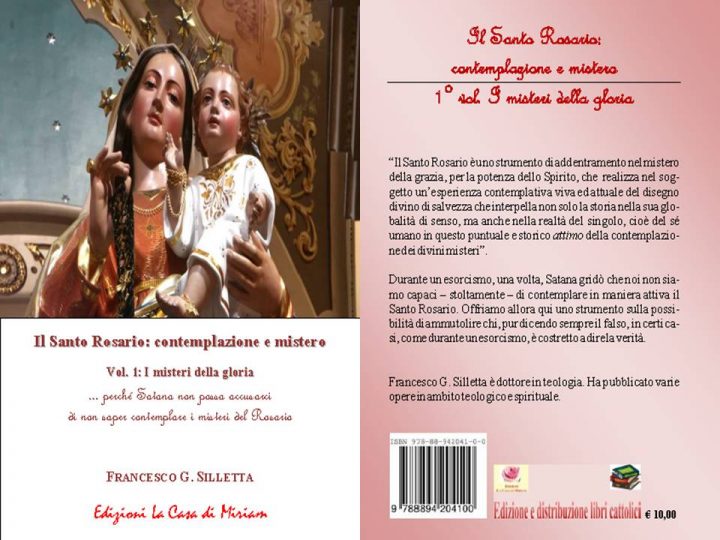 Contemplare il S. Rosario mistero per mistero. Essere presenti con tutto l’intelletto, con tutta l’immaginazione e ovviamente con tutto il nostro cuore a quanto ivi meditiamo. Ciò che ci viene estrinsecamente dato, ossia i titoli dei vari misteri da meditare, può essere intrinsecamente elaborato, formalizzato e, infine, davvero vissuto da parte nostra. Si può cioè fare l’esperienza viva, reale, attraverso il dono dello Spirito che infonde in noi la fede, di quanto Gesù ha storicamente vissuto, interpellato, realizzato per noi, nonostante la nostra distanza temporale rispetto a quell’evento unico della storia. Ora, noi ci mettiamo a confronto con i misteri della gloria. Già questo termine, così “sontuoso”, esprime un a-priori teologico: stiamo entrando, meditando questi misteri, in un’area particolarmente “manifesta”, “sontuosa”, “potente” dell’esperienza di Cristo, che in se stesso è espressione vivente della gloria (greco δόξα, doxa) del Padre.
Contemplare il S. Rosario mistero per mistero. Essere presenti con tutto l’intelletto, con tutta l’immaginazione e ovviamente con tutto il nostro cuore a quanto ivi meditiamo. Ciò che ci viene estrinsecamente dato, ossia i titoli dei vari misteri da meditare, può essere intrinsecamente elaborato, formalizzato e, infine, davvero vissuto da parte nostra. Si può cioè fare l’esperienza viva, reale, attraverso il dono dello Spirito che infonde in noi la fede, di quanto Gesù ha storicamente vissuto, interpellato, realizzato per noi, nonostante la nostra distanza temporale rispetto a quell’evento unico della storia. Ora, noi ci mettiamo a confronto con i misteri della gloria. Già questo termine, così “sontuoso”, esprime un a-priori teologico: stiamo entrando, meditando questi misteri, in un’area particolarmente “manifesta”, “sontuosa”, “potente” dell’esperienza di Cristo, che in se stesso è espressione vivente della gloria (greco δόξα, doxa) del Padre. “Le lacrime della Madre in qualche modo riguardano sempre un dolore che generiamo in noi stessi, attraverso un nostro dato modo di essere e del quale non siamo consapevoli. L’amore è così, anche dal suo punto di vista “negativo”: lo slancio vitale con il quale si comunica gratuitamente, infatti, viene alle volte respinto e sommerso da una pretestuosa nostra autosufficienza, invisibile ai nostri occhi ma chiara, estrinseca nei suoi effetti deleteri e futuri agli occhi onniveggenti di Maria, il cui pianto è espressione reale, somatica, di un indicibile dolore che riguarda la nostra esistenza personale. Sorridere ironicamente delle immagini che raffigurano l’Addolorata è un attestato esplicito di una bassa disposizione verso l’amore oblativo, che per pura pietà non esprime categoricamente e tumultuosamente la propria attualità ontologica, bensì attenua il proprio impeto attraverso una categoria di mediazione di ordine materno: la Madre” –
“Le lacrime della Madre in qualche modo riguardano sempre un dolore che generiamo in noi stessi, attraverso un nostro dato modo di essere e del quale non siamo consapevoli. L’amore è così, anche dal suo punto di vista “negativo”: lo slancio vitale con il quale si comunica gratuitamente, infatti, viene alle volte respinto e sommerso da una pretestuosa nostra autosufficienza, invisibile ai nostri occhi ma chiara, estrinseca nei suoi effetti deleteri e futuri agli occhi onniveggenti di Maria, il cui pianto è espressione reale, somatica, di un indicibile dolore che riguarda la nostra esistenza personale. Sorridere ironicamente delle immagini che raffigurano l’Addolorata è un attestato esplicito di una bassa disposizione verso l’amore oblativo, che per pura pietà non esprime categoricamente e tumultuosamente la propria attualità ontologica, bensì attenua il proprio impeto attraverso una categoria di mediazione di ordine materno: la Madre” –“Medjugorje: tutti i messaggi.
Con introduzione al concetto di rivelazione privata”
Un estratto
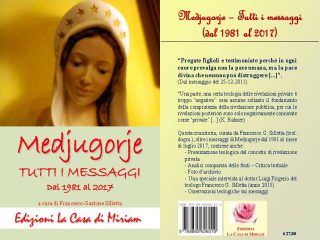
“Guarire con Maria.
Itinerario di preghiera per una guarigione interiore”
Francesco G. Silletta
 Un percorso di spiritualità con insegnamenti, preghiere, letture argomentate ed immagini, secondo l’insegnamento della Chiesa, per ottenere la pace dello spirito nella semplicità della preghiera quotidiana.
Un percorso di spiritualità con insegnamenti, preghiere, letture argomentate ed immagini, secondo l’insegnamento della Chiesa, per ottenere la pace dello spirito nella semplicità della preghiera quotidiana.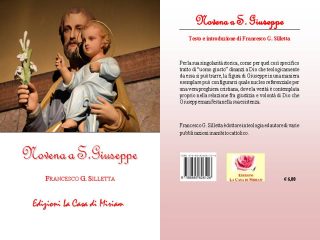 NOVENA A SAN GIUSEPPE
NOVENA A SAN GIUSEPPE “Attirami, noi correremo (Ct 1,4). Quando la santità è donna. Tratti esistenziali di 12 sante”
Francesco G. Silletta
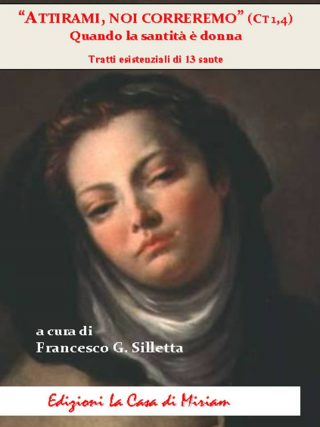 La storia di Cecilia Eusepi, della Beata Eustochio, della Beata Liduina di Schiedam, di Maria Esperanza, di santa Teresina di Liseux, di Teresa Newmann, di Francesca Lancellotti e di santa Maria bertilla Boscardin e di altre sante.
La storia di Cecilia Eusepi, della Beata Eustochio, della Beata Liduina di Schiedam, di Maria Esperanza, di santa Teresina di Liseux, di Teresa Newmann, di Francesca Lancellotti e di santa Maria bertilla Boscardin e di altre sante.“Meditazioni con Filotea”
– di Elsa Bertilla Sinico
 L’autrice confronta la propria esistenza alla luce di Filotea, il personaggio inventato da san Francesco di Sales
L’autrice confronta la propria esistenza alla luce di Filotea, il personaggio inventato da san Francesco di Sales“Petali di una camelia: storia vera di un convertito” – di N. Ros e L. Vador
 La storia vera di Vincenzo Ferrari, che dopo tanti anni lontano da Dio vive una singolare esperienza di conversione e di vicinanza della Madonna – Il linguaggio e lo stile sono romanzati, ma la storia è reale come anche disponibile al colloquio il protagonista stesso.
La storia vera di Vincenzo Ferrari, che dopo tanti anni lontano da Dio vive una singolare esperienza di conversione e di vicinanza della Madonna – Il linguaggio e lo stile sono romanzati, ma la storia è reale come anche disponibile al colloquio il protagonista stesso.TUTTI I LIBRI IN VERSI
DI GABRIELLA MANTOVANI:
 “Una piccola sfumatura” –
“Una piccola sfumatura” –  “Di sole parole” – Antologia poetica
“Di sole parole” – Antologia poetica“In te sembra che Adamo non sia passato”
(su una frase di Alessandro di Hales rivolta a San Bonaventura)

Una frase di un maestro di San Bonaventura, Alessandro di Hales, riferita al “dottore serafico” di Bagnoregio, può farci molto riflettere su tante cose:
“In te sembra che Adamo non sia passato”.
Il teologo, maestro del futuro Dottore della Chiesa, si riferiva alla purezza ed alla limpidezza tanto del cuore quanto dell’intelletto del giovane studente, che egli ebbe il dono di incamerare tra i propri allievi.
“Adamo che non passa in noi”: potremmo porci a nostra volta la stessa questione. Certo è vero, si tratta evidentemente di un’immagine che – tanto più se pronunciata da un teologo così preparato – parte ovviamente dal presupposto che tutti siamo figli di Adamo in quanto all’eredità del peccato originale. Tuttavia vi è una possibilità realistica in questa frase, e forse non solo per il santo Bonaventura, ma anche per noi, alle prese con le nostre molto meno “serafiche” debolezze umane. La possibilità, cioè, che quanto di “adamitico” abbia attraversato la nostra esistenza, possa rimanere innocuo, nonostante la gravità del suo giogo, ora assuefatto integralmente dalla luce di Cristo che si rispecchia in ogni latitudine della nostra vita. Essere apertamente visibili in quanto opera di Cristo che si muove ed esiste nel mondo, senza camuffamenti né compromessi con il mondo stesso, luminosi, radiosi nella nostra speranza verso il bene eterno del Cielo.
Ad alcuni una realtà di questo genere può certamente dar fastidio, così come dava fastidio la stessa santa e coltissima intelligenza di Bonaventura a suo tempo. E tuttavia per molti altri una tale realtà esistenziale non può che rivelarsi contagiosa ed indurre verso la medesima celestiale imitazione.
Così anche noi, come Bonaventura, potremmo iniziare da oggi a vivere e a testimoniare Cristo nel mondo “come se in noi Adamo non fosse mai passato”.
Amen
Preghiera speciale
a S. Michele Arcangelo

Per alcuni che dimenticano il valore dell’Eucaristia:
un estratto dalla “Ecclesia de Eucharistia”,
di S. Giovanni Paolo II:
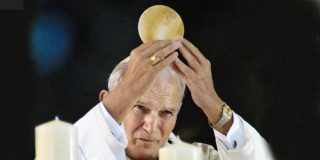
UNA BELLISSIMA RIFLESSIONE DI
J. H. NEWMAN (SANTO) SUL CRISTIANESIMO:
Da un sentimento di invidia non gestito,
può scaturire una possessione diabolica o un'ossessione psichica
nel soggetto che lo attualizza:

Tra le varie ragioni per cui Satana viene a dimorare in un corpo, lo si comprenda, non vi sono solo quelle connesse alle frequentazioni di indovini, maghi, prostitute e via dicendo, pur essendo tutte forme, queste, di un suo facile ingresso nell’esperienza personale di un soggetto.
In molti casi, infatti, la sorgente del suo ingresso nell’economia esistenziale di una persona, come se uno gli avesse aperto la porta della propria vita, è un misconosciuto sentimento di invidia per il bene dell’altro, esistente nel proprio cuore, una sofferenza per il successo dell’altro sul posto di lavoro, nella sua famiglia, nella sua vita in genere. Facciamo attenzione perché da un sentimento di invidia può germogliare un odio incontrollato ed imperituro verso l’altro difficilissimo da estirpare dal proprio cuore e che, non meno di altre cattive azioni, può davvero far permanere Satana in sé e far scaturire fenomeni ossessivi e/o addirittura possessivi, nella misura in cui esso conduce a cattive derive comportamentali (ad esempio l’invidia verso qualcuno può condurre ad augurargli il male, a consultare un mago, a fargli il malocchio o a commettere direttamente atti di violenza nei suoi riguardi, ecc.)
Quando Gesù ci esorta a pregare per i nostri nemici, ci vuole proprio tutelare rispetto a questo rischio intrinseco ad un sentimento di protratto risentimento verso l’altro, che in ultima istanza relega il soggetto che lo vive ad una condizione di schiavitù verso Satana che lo ispira (e tanto più lo fomenta, dal momento che se percepisce che una persona con il suo comportamento urta il nostro autodominio, tanto più istigherà quella persona a comportarsi in quel modo nei nostri riguardi).
Amen.
Edizioni Cattoliche e Cenacolo La Casa di Miriam 24h
Piazza del Monastero, 3 – Torino
www.lacasadimiriam.altervista.org
Francesco Gastone Silletta – Santuario della Consolata – di Torino:

Dio sia benedetto
Benedetto il suo santo nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo sacratissimo Cuore
Benedetto il suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù, nel santissimo Sacramento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima
Benedetta la sua immacolata Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo Sposo
Benedetto Iddio, nei suoi Angeli e nei suoi Santi
Sulle espressioni Figlio di Dio e Parola di Dio
riferite a Cristo

Proprio mentre preparavamo questo articolo ci balzava agli occhi – casualmente – una notizia di qualche anno fa (non che le cose siano molto cambiate, tuttavia) – di come in Pakistan desse fastidio ad alcuni cosiddetti “estremisti musulmani” che i cristiani (dentro la loro Chiesa, nb.) usassero l’espressione “Figlio di Dio” riferita a Gesù Cristo.
L’espressione è tuttavia fondamentale per la nostra fede cattolica – purché compresa sino in fondo – come anche l’altra espressione, molto citata in questa ricorrenza odierna voluta da Papa Francesco, ossia “Parola di Dio”. Si tratta di due espressioni, infatti, che pur vere e cattolicamente inappellabili, in realtà rischiano un’ambiguità di ordine più teologico che semantico. Figlio è tale, infatti, del Padre. La Parola è “divina”, a sua volta, in quanto “del Padre”. La specificazione “di Dio” dopo il termine Figlio e dopo il termine Parola, in tal senso rischia di creare un’ambiguità teologica qualora appaiano disgiunti da una parte Dio e dall’altra il suo Figlio/Parola. Come se, appunto, da un lato ci fosse Dio, dall’altro il suo Figlio (Figlio di Dio) e la sua Parola (Parola di Dio). Quando Caifa, Sommo Sacerdote, vuole disintegrare ogni dubbio sull’identità di Gesù (a sua volta in qualche modo “somigliante” – nell’intolleranza verso l’espressione “Figlio di Dio” – a quegli estremisti citati sopra), pone al diretto interessato (Gesù) la domanda circa la sua filiazione in termini teologicamente ambigui (nel senso di arzigogolati): “σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;” (ossia letteralmente: “Sei tui il Figlio del Benedetto?”). Gesù risponde affermativamente; pur tuttavia, quando deve descrivere se stesso, dinanzi al sommo sacerdote preferisce riutilizzare l’espressione “Figlio dell’uomo” per parlare di sé: “ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως” (ossia “seduto alla destra della Potenza” – Cfr. Mc 14,61-62). La famosa professione di fede di Pietro, a suo modo, evidenzia ulteriormente la questione: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος – Mt 16,16). Allo stesso modo l’esclamazione di Natanaele ad inizio del Vangelo di Giovanni: “ῥαββεί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ” (Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, Gv 1,50). Si tratta infatti di due affermazioni certamente vere, da un punto di vista teologico fondamentale, pur tuttavia in certo modo equivoche, complice il fatto – che Gesù considera – dell’inesperienza teologica dei suoi due apostoli. La filiazione affermata in Gesù, realtà vera in cui crediamo, è infatti riferibile unicamente al Padre. Dire “Figlio di Dio”, dentro una tradizione ebraica in cui anche il popolo d’Israele poteva essere denominato così, come pure alcuni singoli e particolari uomini della storia di quel popolo, non esprime in sé tutta la pregnanza semantica di questo termine applicato a Gesù, la cui persona, ricordiamo è sempre e solo quella divina, nonostante la duplice natura. Lo stesso discorso vale per il termine “Parola”(Verbo) di Dio. Giovanni, nel suo prologo, chiarisce ogni dubbio dicendo subito che “Il Verbo era Dio”. Se identificata con Dio stesso, la Parola/Verbo non può propriamente essere “di Dio”, ma appunto “del Padre”. Non è dunque certo errata l’espressione Parola di Dio, laddove più che un complemento di specificazione, in quel “di Dio” si intraveda una qualificazione della natura della stessa parola, cioè l’essere divina. Se considerata da un punto di vista “personale”, tuttavia, la Parola è sempre del Padre, come il Figlio è tale sempre in riferimento al Padre. Forse quegli estremisti islamici di cui abbiamo parlato sopra – e con loro i neo-eredi del pensiero di Caifa – potrebbero quantomeno riflettere un po’ su ciò che tanto detestano, il Cristo, il Figlio/Parola del Padre, Dio Egli stesso da un punto di vista prima semantico e poi teologico, e capire perché la fede cattolica giustamente crede in lui come Figlio/Parola di Dio.
Amen.

“Cristo è prima delle sue figure,
anche se appare dopo di esse in quanto essere storico”
– dal libro di H. de Lubac, Cattolicismo:
“Per il sangue di Gesù”
Dal libro “Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” –
4 volumi – di Francesco G. Silletta – Edizioni La Casa di Miriam:
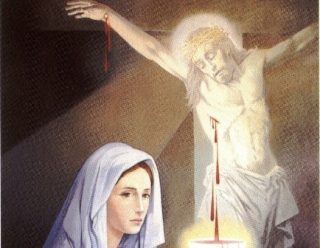
“Gesù ha sete, ma è lui che dà da bere” –
dal libro “Amato perché amante” – di Francesco G. Silletta
– Edizioni La Casa di Miriam – Nelle librerie cattoliche:

“[…] la sete di Gesù descritta in Gv 19,28 (“Ho sete”) deve essere inquadrata entro la medesima orbita del simbolismo giovanneo (causa reale), senza per questo violare la sua stessa radice storica (causa occasionale). In questa prospettiva, è fondamentale riuscire a leggere il passo dove questa sete viene affermata (19,28) in linea di continuità con quanto segue, cioè la “consegna” dello Spirito da parte di Gesù (19,30) e il colpo di lancia con il quale venne trafitto (19,34). Soltanto leggendo assieme questi brani, infatti, si può cogliere il senso più profondo della sete di Gesù, che ha una natura eminentemente spirituale. Come afferma il de la Potterie, a riguardo, “facendo un parallelo con la scena della samaritana, in cui Gesù parla ugualmente di sete e in cui si apre una prospettiva sull’acqua viva che egli darà, si nota in entrambi i casi un capovolgimento della situazione. All’inizio è Gesù che ha sete e che chiede alla donna di dargli da bere; anzi, il dialogo cambia rapidamente direzione e colui che chiedeva da bere diviene colui che darà da bere” . La stessa strategia redazionale viene applicata anche alla sete di Gesù sulla croce (19,28): “Gesù esprime un desiderio: ‘Ho sete’, ma il testo passa al piano superiore: “Egli diede lo Spirito”. Colui che chiede è colui che dà!” (Ivi) . La sete di Gesù va allora intesa come il suo estremo desiderio di comunicare lo Spirito, cosciente di avere adempiuto interamente la propria missione terrena (τετέλεσται) e di voler ora instaurare una nuova era storico-salvifica, cioè il tempo dello Spirito. In questo senso, allora, dicendo: “Ho sete” (Διψώ), dopo che tutto era stato compiuto di ciò che atteneva alla sua rivelazione messianica (είδώς ό Ιησους ότι ήδη παντα τετέλεσται), Gesù grida al Padre la sua vittoria, e in questo senso trionfale (causa reale) va dunque intesa la stessa sete di Gesù […]”
(Francesco G. Silletta – “Amato perché amante. Il discepolo amato come personaggio in migrazione” – Edizioni La Casa di Miriam – Nelle librerie cattoliche – Info: Tel. 3405892741)
Cesare de Bus (santo)

Dal libro di Fernando Rea, “Un Catechista”, Marietti, Roma 1963, pp. 62-67.
[…] Al contrario del gusto degli oratori sacri dell’epoca che amavano sovraccaricare i loro sermoni di greco e di latino, di citazioni profane e di allusioni mitologiche per distinguersi con simile sfarzo di erudizione, Cesare sdegnava ogni rinomanza ed era fermo allo scopo che si era prefisso fin dalla prima volta che era salito in pulpito: non dire mai nulla che non tendesse alla maggior gloria di Dio e profitto alle anime. La ponderata lettura dei Santi Padri e la pietà gli avevano ispirato il buon gusto dell’eloquenza sacra. I suoi catechismi, le sue prediche, erano composte in uno stile così naturale, elegante e devoto che entusiasmava alla pietà chi l’ascoltava. La sua eloquenza era senza sfarzo e accessibile a tutti: le sue parole familiari e comuni, ma proprie, atte a suscitare l’attenzione e a prevenire in suo favore la stima e l’affetto degli uditori. Non ricusava mai di andare a predicare dovunque richiedessero la sua presenza e talvolta affrontava viaggi faticosi che lo spossavano, ma era ben lieto di soffrire qualche disagio nell’annunciare la parola di Dio.
Nei giorni festivi il canonico de Bus predicava nella cattedrale di Cavaillon con tale profondità di dottrina e con tale soddisfazione dei fedeli che se ne conservò il ricordo per molti anni dopo la sua morte. I documenti dell’epoca ci informano che tanta era la folla di uditori che gremivano la chiesa dove parlava, che era necessario procurarsi il posto due o tre ore prima. Non era raro il caso che le sue parole suscitassero tra i fedeli un subitaneo e sentito pentimento. Una volta una dama di Cavaillon, dopo aver assistito ad una predica del de Bus, si alzò dal suo posto piangente per i propri peccati e, dirigendosi verso il predicatore, a voce alta lo supplicò di volerla confessare perché se non l’avesse fatto subito non l’avrebbe fatto più.
Oltre che dal pulpito si distinse, in modo del tutto particolare, nel confessionale, dove rimaneva dalle cinque alle sei ore, talvolta fino a sera inoltrata. La schiera dei penitenti che chiedevano di potersi confessare dal canonico de Bus aumentava sempre di più e, a qualsiasi ora del giorno, andavano a cercarlo perfino in casa.
Padre Cesare era sempre pronto, affabile e non faceva mai aspettare nessuno per timore di lasciar fuggire quei momenti favorevoli ad un sincero pentimento che, con ogni probabilità, non sarebbero mai più tornati. Quanti si presentavano erano benvenuti, i poveri come i ricchi, senza alcuna distinzione, se non per i più bisognosi, gli ignoranti, gli infermi. Dotato di finissima intuizione, quando gli si avvicinava un qualche penitente, vedeva e scopriva ciò che aveva nel cuore e, con grave commozione, gli diceva quello che non poteva liberamente cavargli dalla bocca, ma con una maniera così delicata e affettuosa che lo costringeva a confessare ogni più segreta colpa. Non vi era imbarazzo di coscienza che non dissipasse, non passione dissimulata che non conoscesse, non imperfezione nascosta che non scoprisse, non amor proprio così celato che non sfuggisse al suo rimprovero
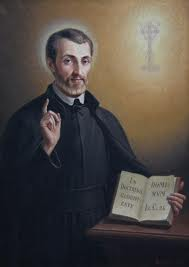
L’anima di Cesare de Bus ardeva di amor santo di Dio e, considerando le tristi condizioni in cui si trovava il clero di Cavaillon, con l’approvazione del vescovo Monsignor Escot, pensò alla costituzione di una pia confraternita tra ecclesiastici da porre sotto il patrocinio di San Bernardo. Sarebbe stata una scuola di virtù, fiamma ardente che avrebbe riacceso lo zelo all’apostolato. Una simile fondazione che legava ciascun iscritto nel comune intento di progredire nella santità, si diffuse in tal modo che, più tardi, si ritenne opportuno di ammettervi anche qualche laico particolarmente dotato.
I congregati che regolarmente si incontravano in riunioni e conferenze il cui fecondo animatore era de Bus, non tardarono a manifestarsi come uomini nuovi ed il loro rinnovamento spirituale si estese beneficamente ad altri confratelli e nelle chiese di Cavaillon.
A rendere stabile una così bella e salutare istituzione, dopo averne compilati i relativi regolamenti, illuminati di cristiana prudenza, si ottenne da papa Gregorio XIII un Breve di erezione. Nel documento pontificio si faceva una particolare menzione del canonico Cesare de Bus che veniva nominato primo Rettore di detta Confraternita. In questa occasione furono pure accordate speciali indulgenze a quanti si fossero ad essa aggregati.
L’ambìto riconoscimento da Roma era una conquista per Cesare de Bus che, in questo periodo, spinto dall’amore per la penitenza e la solitudine, lasciò la casa paterna e fissò la sua dimora in una cella oscura, angusta e malsana nel chiostro della cattedrale. In questa specie di volontaria prigionia rimase per ben tre anni, non potendo il suo spirito umile, sobrio ed austero conciliarsi con i riguardi affettuosi che riceveva in casa dalle sorelle, con i piaceri della tavola che vi si imbandiva e l’agiatezza che vi abbondava. Una vita da eremita, confortata oltre che dalla preghiera e dalle grazie che il Signore gli elargiva, dalla compagnia del buon amico Don Ferriol, che, di tanto in tanto, lo andava a visitare.
Era logico che parenti e amici sopportassero, di malumore, l’austera vita claustrale di Cesare e cercassero in ogni modo di rimuoverlo da una simile intenzione che a loro sembrava degna di un folle. Tutto il giorno rimaneva chiuso nella fredda celletta, la cui finestra si apriva su di un cortiletto adornato da una doppia fila di eleganti colonnine del chiostro. Al centro, circondata di piante e su di un basamento di pietra, una antica immagine della Madonna con il Bambino. Lasciava la cella solo per celebrare la Messa in cattedrale o per passeggiare lentamente nel recinto del chiostro.
Ai digiuni che già fedelmente praticava il venerdì e il sabato, aggiunse la più rigorosa astinenza dalle carni come dal pesce per l’intera settimana e al cilicio che indossava, sostituì una maglia di ferro che portava giorno e notte sulla carne nuda. Tanta era la sofferenza che gli recava un simile supplizio, che dopo circa sei mesi dovette ritornare all’uso del cilicio.
Per giaciglio aveva solo poca paglia ed una povera coperta. La scarsezza e la cattiva
qualità dei cibi che prendeva, la povertà squallida della dimora, la semplicità dell’abito, tutto accusava il rigore severo della sua penitenza che rese ancora più austera quando lesse un libro sulla vita del Cardinale Borromeo.
Per attendere più a lungo alla preghiera e alla meditazione, rubava al riposo la maggior parte della notte. Si levava dal pagliericcio quando fuori era ancora buio e, senza nemmeno accendere la lucerna, si prostrava lungo, disteso per terra, in orazione. Prendeva quella scomoda posizione in segno della sua meschinità di fronte a Dio, creatore del cielo e della terra e, talvolta, poneva delle pietruzze sotto le ginocchia per stare ancora più scomodo. Rimaneva lunghe ore assorto nella contemplazione consolante delle verità eterne, innalzandosi con la mente sopra tutto il creato, ammirando le infinite perfezioni di Dio, riguardava poi le cose e gli avvenimenti, che più ci affannano in questo mondo, come un’ombra che si dilegui in un batter d’ali. Il pensiero era talmente preso dalla considerazione dell’onnipotenza di Dio, da renderlo completamente insensibile al mondo esterno. Scendeva poi con il pensiero sulla propria nullità, sull’ardimento avuto nell’offendere la Maestà Divina e, pieno di vergogna, piangeva i peccati commessi.
In questo periodo di santa solitudine, mise mano ad alcune opere letterarie che poi, ultimate più avanti negli anni, offriranno al lettore il quadro più completo della vivida spiritualità di Cesare de Bus. Compose bellissimi dialoghi tra l’anima e Dio, un catechismo per fanciulli, discorsi sul Cantico dei Cantici, appunti su omelie intorno alla spiegazione del Vangelo domenicale. La vita di sacrificio e di stenti che si era imposto, non tardò a far sentire i suoi effetti. Un’acuta infiammazione agli occhi lo faceva lacrimare quando era esposto alla troppa luce, mentre le sue membra, prima robuste, apparivano affaticate. A causa del persistente arrossamento degli occhi, dovette interrompere gli studi cui si dedicava con profitto, offrendo ogni sofferenza al Signore. Malgrado la salute malferma, non tralasciò mai di visitare gli ammalati e chi soffriva più di lui. Si intratteneva amorevolmente presso il loro capezzale. Diceva loro parole di conforto e, dolcemente, quando ne erano lontani, li riportava all’osservanza della legge di Dio.

Vale la pena, a riguardo, rammentare un fatto che ha del soprannaturale. Maddalena de Chassain, gentildonna di Cavaillon, era da lungo tempo affetta da male grave ed incurabile. Ridotta in condizioni così disperate, i medici non potevano fare altro che consegnarla per prepararsi a ricevere i Sacramenti. Questo consiglio fece disperare la povera inferma che si lamentava di giorno e di notte perché non voleva morire. Qualsiasi tentativo per farla avvicinare da un sacerdote era stato vano, rigettava imprecando qualsiasi persona che parlasse di religione e di Dio. Ostinata in questo folle pensiero, non si trovò nessuno che riuscisse a persuaderla. Cesare de Bus, venuto a conoscenza dell’ostinazione di quella nobildonna, non tardò a recarsi di persona in casa dell’inferma.
Tanta era la fama di santità di quel sacerdote che Maddalena de Chassain non lo fece cacciar via dai servi ma, con rispetto, l’ascoltò, pur non accondiscendendo a confessarsi. Visto come ogni tentativo fosse inutile, de Bus, ispirato certamente da Dio, con voce solenne assicurò la malata che qualora si confessasse, pentendosi sinceramente dei propri peccati, avrebbe riacquistato non solo la salute dell’anima ma anche quella del corpo. Il Signore volle che, per intercessione del suo servo Cesare de Bus, così realmente avvenisse.
Madama de Chassain fu per tutta la vita grata al Signore per la grazia ricevuta e visse ancora lunghi anni, esempio di virtù per la città di Cavaillon.
Fonte: Edizioni La Casa di Miriam Torino
Imparare a pregare
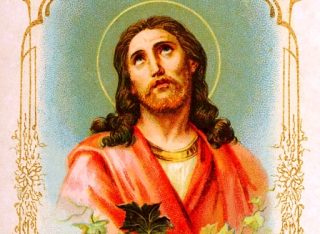
“Questa legge è posta per tutti, ma non per te” (Est 15,13):
sull’Immacolata Concezione di Maria – da un articolo di Agostino Bea:

[…] Dovrebbe certo sorprendere se la Madre di Dio, la quale avrebbe avuto nel NT una parte tanto importante nella Redenzione, non fosse stata preconizzata nella funzione preparatoria insita nell’AT; ma i santi Padri e la Chiesa, particolarmente nella liturgia, hanno attinto già per tempo a questa fonte per esprimere la grandezza e la magnificenza di Maria. […]
Immagini prefiguratrici di Maria:
– l’Arca di Noè che, costruita per ordine di Dio, rimase completamente salva ed intatta nel generale naufragio;
– la scala che Giacobbe vide toccare il cielo e sui gradini della quale angeli di Dio salivano e scendevano, e in cima alla quale era Dio stesso;
– il roveto che Mosè vide ardere tutto in giro in luogo consacrato e, nonostante le fiamme guizzanti, non bruciare né patir danno, ma verdeggiare e fiorire magnificamente;
– la torre inespugnabile per qualsiasi nemico, dalla quale pendono mille scudi e l’intera armatura del forte eroe;
– il giardino chiuso che non è violabile o devastabile per nessun artificio di inganno;
– la fulgente città di Dio, le cui fondamenta poggiano su sacri monti;
– l’augusto tempio di Dio che rifulge di divino splendore ed è colmo delle magnificenze del Signore e, infine, numerose altre raffigurazioni del genere
[…] Fra le figure femminili bibliche di maggior rilievo del Vecchio Testamento non poche ve ne sono che si riscontrano somiglianti, anche se soltanto dopo aver attribuito loro una perfezione maggiore, una più spiccata levatura, alla Madre di Dio. Già in precedenza abbiamo accennato al ravvicinamento tra Eva, la madre di tutti i viventi, e Maria, che ci ha donato la vera vita. Il raffronto tra Maria ed Eva è quasi altrettanto antico che il Cristianesimo; già san Giustino martire (morto fra il 163 e il 167) vi ha accennato nella sua disputa con il Giudeo Trifone; Ireneo, Tertulliano, Origene, Agostino lo hanno ulteriormente sviluppato, e da allora non è più scomparso dalla Chiesa. Il gioco di parole caro ai Padri: “Eva-Ave” si riscontra nel mutans Evae nomen dell’Ave Maris Stella, come testimonianza permanente di questa credenza.
È indubbio che Giuditta ed Ester costituiscano, per la loro azione di salvatrici, simboli egregi della Madre di Dio apportatrice di salute e di salvezza. E come Giuditta recide il capo al condottiero dei nemici del popolo di Dio, Maria schiaccia il capo al peggiore nemico, a Satana. Così, pertanto, la Chiesa rivolge nella sua liturgia quello stesso canto di lode a Maria, che era stato rivolto alla eroina Giuditta dal popolo liberato dopo la sconfitta del nemico: “Tu sei la gloria di Gerusalemme, l’allegrezza d’Israele, l’onore del nostro popolo” (Gdt 15,10).(cfr. Gdt 13,23-25).
Infine Ester che, scelta a regina fra molte vergini, mette a repentaglio la propria vita per salvare il suo popolo dalla rovina che incombe, ed ode dirsi dal re queste affabili parole: “Questa legge è posta per tutti, ma non per te” (Est 15,13), è per noi una raffigurazione familiare della Immacolata Concezione, e come regina che col suo coraggioso intervento salva il suo popolo dalla rovina, è divenuta per noi il simbolo della regina celeste che conquista e riconcilia il cuore di Dio per la salute dell’umanità.
[Agostino Bea, La figura di Maria nel Vecchio Testamento, pp. 21-40, in P. Sträter, (a cura di), Katholische Marienkunde, 1952, tr. it. Mariologia, III Voll., Marietti Editori Pontifici, Roma 1955]
“Sul rapporto fra uomo di peccato e uomo Figlio di Dio” –
estratto dallo studio di Francois-Xavier Durwell,
“La risurrezione di Gesù. Mistero di salvezza” – pp. 49-50

“Così come a motivo della carne, Cristo è condannato anche a causa della legge: la maledizione con la quale essa colpisce un popolo trasgressore (Gal 3,10) pesa pure su di lui che appartiene a quel popolo secondo la carne. Tale appartenenza dà luogo a una reazione catena: “Nato da donna (ebrea), nato sotto la legge”, è colpito da maledizione e muore in croce (Gal 4,4; 3,13). In Gal 2,19 Paolo scrive: “Sono morto alla legge”, espressione che va intesa in questo modo: con Cristo, al quale sono unito, sono morto alla legge.
Nessuno viene salvato per il solo fatto di morire. La morte non abolisce affatto la carne e la sua debolezza, o l’appartenenza al peccato e il regno della legge: li consacra e li proclama, invece. Se fosse soltanto morto, Cristo non avrebbe fatto altro che soccombere, come gli altri, alla morte. La sua morte, invece, è liberatrice. Essa annulla ciò di cui è l’emblema. Morendo a causa del peccato, della debolezza della carne e delle esigenze della legge, Cristo muore a tutto ciò. Prima di tutto al peccato: “Mandando il suo Figlio in una carne simile a quella del peccato… Dio ha condannato il peccato nella carne” (Rm 8,3). Sulla croce Dio abolisce il nostro peccato nella carne di Cristo: “Il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato” (Rm 6,6). San Paolo suppone che il corpo del peccato sia stato distrutto prima di tutto in Cristo: “Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato” (Rm 6,10). Ormai egli è senza peccato, come si azzarda a dire Eb 9,28.
Egli muore alla sua debolezza, poiché “morì una volta per tutte” (Rm 6,10) e non è più sottomesso alla mortalità. Non avendo ormai alcuna relazione con il peccato, la sua parusia si compirà con potenza.
Muore alla legge. L’apostolo dice di essere morto alla legge perché è unito a Cristo che è morto alla legge (Gal 2,19). Ogni cristiano condivide tale privilegio: “Anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge, mediante il corpo di Cristo” nel quale la legge si è estinta (Rm 7,4; cfr. Ef 2,15). Sulla croce è stato inchiodato e annullato il debito contratto con la legge (Col 2,14).
Dopo di ciò, si rivela in Gesù un essere nuovo. Prima “nato secondo la carne”, secondo la condizione degli uomini da salvare, viene poi “costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione” (Rm 1,4), cioè conforme alla sua santità primordiale. A colui che si è spogliato di se stesso fino alla morte, Dio accorda il nome sovrano, la potenza e la gloria divine, così che l’universo proclami che “Gesù Cristo è il Signore” (Fil 2,9-11). Colui che Dio “ha fatto peccato” (2Cor 5,21) è diventato “giustizia… e santificazione”(1Cor 1,30).
Nelle fasi successive della sua esistenza, Gesù Cristo si presenta in maniera contrapposta come un uomo nella carne di peccato e di debolezza e un uomo Figlio di Dio nella santità e potenza. Gesù passa dall’uno all’altro come in un processo di giustificazione […]”
“Preghiera di liberazione alla Madre di misericordia”
– di Francesco G. Silletta
dal libro “Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” (3 volumi) –
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam – Tel. 3405892741 – Torino

Preghiera per l’illuminazione della coscienza
(dal libro “Liberaci dal male” di Francesco G. Silletta)
Signore nostro Dio, che hai detto “la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto” (Is 58,8), noi ci raduniamo qui alla tua presenza, supplicando da te luce e perdono. Luce, per vedere e comprendere le volte che ti abbiamo rifiutato, non ti abbiamo reso attenzione e abbiamo trascurato il tuo consiglio (cfr. Pr 1,24-25); perdono, perché ci siamo affidati alle nostre umane ricchezze, e “la ricchezza rende malvagi” (Ab 2,5).
Tu conosci il nostro cuore, Signore, ed ogni nostro segreto ti è noto: “Può un uomo frodare Dio?” (Mal 3,8). Eppure anche noi ti abbiamo frodato ed ora rimaniamo vittime del nostro agito. Ora noi di supplichiamo, nostro Dio e nostra Verità, affinché le tue orme non rimangano invisibili (cfr. Sal 76,20), affinché ci rendiamo conto del tuo amore misericordioso e purifichiamo la nostra esistenza, perché conoscere te è giustizia perfetta, conoscere te è radice di immortalità (cfr. Sap 15,3).
Invochiamo il tuo Spirito, Signore, affinché governi il nostro pensiero, illumini le nostre scelte, diriga i nostri passi e ci conduca a te. Salvaci dalla paura di essere tuoi discepoli, Signore Gesù, liberaci dall’inclinazione alla fuga ed al ripiegamento su noi stessi. Non rimanere lontano dai nostri cuori (cfr. Ger 12,2) ma rimani accanto a noi, giorno per giorno, manifestandoci te stesso (cfr. Ez 40,4).
Sia lodato il tuo nome, Signore nostro Dio, per tutte le cose che hai creato: tu che hai gli occhi tanto puri da non poter vedere il male (cfr. Ab 1,13), libera la nostra vita da ogni schiavitù e prigionia, perché voli in alto il nostro cuore e possiamo così essere attirati a te (cfr. Os 2,16) ed ivi contemplare il tuo splendore. Amen.

“Liberaci dal male. Preghiere di liberazione” – 4 volumi –
Francesco G. Silletta – Copyright Edizioni La Casa di Miriam
Vergine Santa,
che hai tenuto pura la tua via (Cfr. Sal 118,9),
senza mai comprometterti con il peccato
e hai glorificato l’intera creazione
offrendoti ad essa “con tutti i migliori aromi” (Ct 4,14)
in favore della più eccelsa creatura,
l’uomo immagine di Dio,
che Dio stesso ti ha donato come figlio,
affinché sotto la tutela del tuo manto
trovasse ristoro e consolazione:
aiutaci nella nostra lotta contro le forze del male,
che cercano di insuperbire il nostro cuore
ed ostinarci al peccato (cfr. Dn 5,20).
Liberaci innanzitutto dal dubbio
e dalla mancanza di fiducia nella tua protezione:
tutto ciò che ostacola la nostra conoscenza di te,
dei prodigi del tuo amore,
venga per questo stesso amore immediatamente annullato,
ed al contempo in noi si rafforzi la certezza
di essere sempre sotto la tua protezione materna,
comunque si evolvano le cose della terra
e la nostra esistenza.
Liberaci dal desiderio del mondo,
dall’autonomia di giudizio e di valutazione
che ci conduce ad essere superbi, presuntuosi, autosufficienti rispetto al dono della parola di tuo Figlio.
Liberaci da ogni voce satanica che disturba la pace
e l’armonia della nostra coscienza:
sia sempre rivolta a Gesù, il nostro Signore,
ogni nostra attività mentale e psichica,
affinché mai Satana abbia la vittoria su di noi
attraverso il fomite del dubbio,
l’insinuazione del sospetto
e la malizia del peccato.
Rimani insieme a noi ogni momento,
dolcissima Madre Maria,
perché qualunque demonio
e legione di demoni
siano bruciati via,
lontani da noi,
nelle dimore infernali.
La tua pace ricolmi il nostri spirito e quello dei nostri cari.
Amen.
“Non includere un pensiero ostruttivo, anziché costruttivo, nella tua sete di verità. La verità infatti si comunica di per se stessa, non la si crea né la si costruisce ragionandola.
Non confondere il dono che ti è dato gratuitamente, con quanto di tuo disponi come proprietà autonoma. Sii umile, perché tutto lascerai qui, e sarai giudicato secondo misura di verità”
Amen
MEDITIAMO SPESSO LA PASSIONE DEL SIGNORE
Se davvero pensassimo intensamente alla tua passione e la contemplassimo secondo l’intero potenziale della nostra mente che tu stesso ci doni, proveremmo un tale dolore nel vederti crocifisso che guarderemmo con ribrezzo assoluto qualsiasi anche minimo peccato e ci guarderemmo bene dal commetterlo di nuovo. In tal senso Giovanni Apostolo afferma che chi è nato da Dio non pecca. Per questo, in questo tempo di lassismo morale e di confusione religiosa, immergiamoci nel pensiero (non razionale, ma intuitivo e e contemplativo) della croce di Cristo. Da qui saremo mossi verso una nuova libertà, la libertà dalla schiavitù che il peccato comporta per la nostra vita.
Amen
Al bimbo di Nazaret

Caro Gesù,
che ti fai bambino, al punto che l’Onnipotente
debba essere condotto per mano, affinché impari a muoversi nel mondo,
a distinguere e conoscere le cose, a camminare da solo:
sotto la tua “culla”, che riconosco come teatro del più grande avvenimento della storia, l’Incarnazione del Figlio divino,
voglio porre come dono qualcosa che non si trova in nessun altro luogo, diverso dal mio cuore e che perciò nessun altro potrà donarti,
come ora io faccio con te. Voglio donarti la mia miseria, questo grande contenitore, così pesante nella confezione, dentro il quale uno sopra l’altro sono depositate tante cose, disordinatamente e confusamente.
I miei peccati, la mia disobbedienza, la mia superbia, la mia debolezza, l’irriverenza, l’irascibilità, le mie distrazioni.
Quante cose in un solo dono.
Un dono che solo un Redentore può accettare come tale. Solo un immenso Amore può ringraziare il donante per un gesto del genere. Solo un bambino Onnisciente, che nasconde la propria sapienza entro l’innocenza di un fanciullo, può rimanere incantato per un simile regalo.
Eppure questo è quanto io posso donarti.
Ed oso anche domandarti qualcosa in cambio, per questo dono.
Mi permetto persino, nonostante la natura irriverente del mio dono, di sperare che tu voglia contraccambiarlo in maniera adeguata.
In che modo? Donandomi te stesso. La fede in te.
Amen
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam 24h
Piazza del Monastero, 3 – Torino
www.lacasadimiriam.altervista.org
ATTO D’AMORE A MARIA
(di Francesco G. Silletta)

Vergine Maria,
Io (dire il proprio nome) in questo momento mi pongo alla tua presenza, umilmente, come tuo figlio. Non mi volto né a destra né a sinistra, né verso altra latitudine della mia esistenza. Rinuncio al mio passato e non cerco nulla del futuro: solo mi immergo in quest’attimo presente, tenendo fisso il mio sguardo ed aperto il mio cuore alla santità purissima di te, madre mia, che mi sei dinanzi. Nella mia coscienza in questo momento ci sei solo tu: il mio mondo inizia e finisce con te, per il tempo della mia preghiera. Tu sei mia madre, io lo confesso con gioia. So che per questa maternità non mi abbandonerai mai, né permetterai che io vada perduto. Le mie colpe le conosci, i miei limiti ti sono già presenti, tutto sai di me. Per questo non voglio darti nulla di ciò che già tu conosca. Piuttosto voglio ora darti questo mio momento di intenso amore per te. Voglio dirti che ti amo con tutto il mio cuore e che voglio rimanere sempre con te, sotto la tua protezione. Voglio dichiararti che la tua maternità è la mia più grande gioia, il vincolo che mi lega a te è la certezza della mia pace. Voglio confessarti che nulla mi fa paura di quanto di cattivo e malvagio è nel mondo, poiché so che tu non mi lascerai mai in balia di esso. E se del male abita in me, se qualcosa di negativo percuote la mia pace, so che per questo momento presente, in cui mi trovo davanti a te, tu mi libererai e farai di me una persona nuova, felice, lieta, gioiosa, consapevole che il più grande dono che tuo Figlio potesse darmi, assieme alla sua stessa vita, è la tua maternità.
Ti chiedo questo, madre mia: prendi le mie parole presenti come un sigillo per l’eternità. Se un giorno la vita dovesse confondermi anche solo il tempo di un istante, tu tieni fisso a mente questo mio atto d’amore per te. Ed ogni mia possibile debolezza, ansia o leggerezza mentale o corporale, sia compensata ai tuoi occhi dalla profondità di questo mio intenso atto d’amore per te.
Ora, proprio in questo istante di vicinanza amorevole tra madre e figlio, ti domando protezione, Maria Santissima: innanzitutto per me stesso, per la mia mente, per il mio corpo, per la mia fede, affinché, essendo risanato io per primo, possa a mia volta provvedere a quanti soffrono accanto a me o lontano da me. E dunque curati anche dei miei familiari, di ogni membro della mia famiglia e dei miei amici. Curati dell’umanità intera, che ha bisogno di te come madre, consapevole o meno che ne sia.
Ti supplico, Maria, perché adesso le mie parole termineranno qui: tu però ricordale per sempre, come una preghiera destinata a durare tutto il tempo della mia vita, e se un giorno mi vedrai lontano, chiamami accanto a te per questa preghiera; e se mai mi vedessi triste, o afflitto, o malato, o in difficoltà, guariscimi per queste parole che oggi, in questo breve momento, ho confessato al tuo cuore dal mio stesso cuore.
Io amo te, Maria, come mia Madre. Salvami ora e sempre dal nemico infernale. Amen.
(Testo di Francesco G. Silletta)
Dal libro “Liberaci dal male” (volume 4)
Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam
LA SEPOLTURA DI GESÙ AD OPERA DI DUE GIUDEI
(Gv 19,38-42) -
(dal saggio teologico "Amato perché amante" -
di Francesco G. Silletta - Edizioni La Casa di Miriam):
“Per la benedizione di Gesù” (testo di Francesco G. Silletta)
Signore Gesù, vieni ad aiutarci, quando la notte della paura confonde il giorno della gioia, e quando il giorno dell’euforia confonde la notte del silenzio. Liberaci da ciò che distorce la quiete della nostra natura umana, dalle avversità spirituali che seminano angoscia nella pace del nostro cuore e tentano di disorientarci, di confonderci e di agitarci. Tu sei la nostra pace, in te non c’è contraddizione, tu non ami a tempo, perché sei amore e continui ad espandere la tua bellezza fra le disarmonie dei nostri vissuti, delle nostre intolleranze e personali ambiguità. Aiutaci, allora, ad ancorarci a te, come misura di verità della nostra vita, senza ripensamenti, senza cambiamenti di percorso, senza alcuna tristezza. Per la verità del tuo nome, benedicici, o Signore.
Amen
Preghiera negli stati ossessivi:
Per la tentazione da te patita nel deserto, Gesù,
nella quale hai sottoposto la tua purissima mente umana
alla straziante lusinga del Maligno,
lasciando che egli parlasse – pur senza trovare il tuo assenso alla sua parola –
e lo facesse secondo il suo linguaggio opprimente,
inquietante, falso rispetto alla tua dolcissima verità:
ti domandiamo di annullare come tu hai fatto
ogni riverbero satanico nella nostra mente,
che il Maligno utilizza in modo ossessivo
ricercando in noi una debolezza,
una fragilità, una stanchezza interiore
per manifestarsi egemone
riproponendo in noi continuamente
il medesimo contenuto immaginativo,
locutorio, mnemonico o onirico.
Caccia via da noi ogni esperienza di vicinanza
di qualsiasi genere o forma,
del Maligno a noi,
come tu hai fatto dicendogli
che a Dio solo si rende culto –
e dunque attenzione latreutica –
vanificando nel tuo nome di Signore
ogni ossessione della mente, da lui indotta in noi,
dalle sue parole germinata,
dai suoi sospetti istituita,
dalla sua invadenza prodotta:
tu sei Dio, Gesù,
e nel tuo nome santo ti chiediamo,
supplicandoti con umiltà e fede,
che ciò che ossessivamente –
e dunque non più soltanto a livello temporaneo,
ma con una permanenza protratta –
viene a intralciare la nostra serenità cristiana
per l’invadenza del Maligno,
sia totalmente debellato
e vanificato nelle sue operazioni
di smarrimento, inquietudine e malizia.
Libera, con la tua voce autoritaria,
la nostra mente da qualsiasi ossessione diabolica
sino a divenire tu, Signore e Dio,
l’unico nostro continuo pensiero,
al modo di una ossessione per il nostro e tuo Nemico
affinché avvertendo te, fugga da noi,
e fuggendo da noi
faccia un servizio egli stesso alla nostra pace.
Amen
4 volumi – Liberaci dal male – Edizioni Cattoliche La Casa di Miriam – Tel. 3405892741